Canale Mussolini - Antonio Pennacchi
>> domenica 7 agosto 2011
Sono convinto che questo romanzo sia da considerare tra le grandi opere della letteratura italiana. E questo perchè ha tre grandi meriti.
Il primo, fondamentale, è quello di raccontare tramite la saga di una famiglia uno specifico importante evento (la bonifica delle paludi dell'agropontino) e con questo la storia d'Italia e del fascismo dagli anni venti ai quaranta. A scuola non si studia (esperienza personale) o si studia male e la mia generazione e quella successiva rischia di perdere un pezzo insostituibile di conoscenza che è utile anche come chiave di interpretazione del presente soprattutto nei momenti in cui, come dice Pennacchi, "cambia il vento".
Il secondo è il modo originale, coinvolgente, ironico con cui le vicende sono narrate. Merito anche del linguaggio che alterna un italiano volutamente semplice, da persona che lavora la terra, al dialetto veneto.
Il terzo è quello di aver creato personaggi memorabili, dagli improbabili nomi di battesimo (Pericle, Armida, Temistocle, Adelchi,...), caratterizzati magnificamente e che, anche se immaginari, si intersecano alla perfezione con personaggi storici esistiti e fatti realmente avvenuti.
Come marmo levigato che poco per volta inizia a mostrare crepe sempre più grandi, quella che all'inizio sembra un'agiografia del fascismo si evolve nel corso del libro in una critica che culmina con la descrizione delle nefandezze commesse in Africa. Il tutto rimane in un sottofondo smorzato nei toni a volte comici del libro ed è coerente con il punto di vista dei protagonisti che, come la maggioranza degli italiani, era rimasta affascinata dai vantaggi efficacemente propagandati dal regime totalitario. Interessante la chiave di lettura che Pennachi dà della nascita del fascismo, delle sue adiacenze e diversità dal socialismo, delle cause degli attriti tra le due ideologie e di come una ha prevalso sull'altra e ha attecchito in un Italia scossa dalla prima guerra modiale.
Mussolini è stato grande, ha conquistato tutti. Il capolega non aveva fatto in tempo a dire: «Vi presento il compagno Mussolini», che lui un altro po’ si era mangiato i vetri di tutte le finestre sulla piazza. Non si è messo a sputare sul tricolore come il Rossoni in America, ma poco c’è mancato, creda a me. Lei non ha idea di quello che è stato capace di dire a quei quattro mascalzoni, specie al Giolitti «piemontese falso e cortese», il peggio di tutti secondo lui: «Con tutta la fame che abbiamo qua, e con tutti i poveracci che vengono ogni giorno sfruttati e cavati il sangue dai preti e dai signori, andiamo ad aggredire quei poveri baluba per fare schiavi pure loro? Vergognève!» disse il Mussolini, «Specie il Giolitti e il Bissolati». Come diceva mio nonno, quello era uno che quando doveva dire una cosa la diceva papale papale, non ci stava mica a pensare sopra, non aveva peli sulla lingua.
Una volta – mi pare a Losanna, in Svizzera, quando era scappato anche lui per una condanna – a un prete che sparlava in giro lo fece una pezza da piedi davanti a tutti. Poi da sopra il palco – levatosi l’orologio dal taschino e messolo bene in evidenza sulla balaustra del palchetto – disse proprio: «Ma adesso è ora di farla finita anche con il suo principale, Dio non esiste e ve ne do una prova. Lo sfido. Se esiste, gli do tre minuti di tempo per fulminarmi stecchito su questa pubblica piazza. Se invece non succede niente, vuol dire che non esiste. Tre minuti ho detto, punto e basta», restando in silenzio con l’orologio tirato su per aria, per tre lunghissimi minuti. Ora come lei sa tre minuti, a dirli così, sembrano una cosa da niente; ma si metta in silenzio ad aspettare e veda come sono lunghi. E anche a dire «Io sono ateo; Dio non esiste» non ci vuole niente. Ma lei mi deve credere: quella volta sopra al palco a Losanna era tutto pieno di socialisti atei e mangiapreti, ma appena il Mussolini ha detto «Gli do tre minuti di tempo», la gente piano piano s’è stretta e allontanata; attorno a lui s’è fatto il vuoto.
E lui imperterrito ad aspettare i tre minuti e appena sono passati s’è rimesso l’orologio piano piano nel panciotto riavvolgendo la catenella e ha detto soddisfatto: «Che v’avevo detto io? Sono sano e salvo: Dio non esiste». È scoppiato un applauso che lei non ha idea. Ma anche un sospirone generale di sollievo: «Aaaah».
Comunque finito il comizio – quello nostro del 1911 e della Libia – sceso dal palco, la gente gli si è fatta intorno a salutarlo e coi più stretti sono andati a bere un bicchiere come si fa di solito. Pure mio nonno ha fatto il gesto di avvicinarsi per salutarlo, anche se era un po’ intimidito perché pensava che non si ricordasse. Invece come lo ha visto, il Mussolini ha strillato: «Peruzzi! Am dispiase propi ma stavolta n’an pòi vegnèr a manzàr da valtri, ch’ago d’andar via. Ma nol mancarà ocasiòn, t’al sicuro».
E perché ride adesso? Cosa dice? Lei dice che non può essere che Mussolini parlasse così, perché lui era romagnolo di Predappio, tutto un altro dialetto, un’altra inflessione?
Lei la deve smettere con queste fesserie, io mica sto qui a raccontare barzellette. Cosa vuole che ne sappia io di quale dialetto e con quale inflessione parlasse Mussolini? Quelle sono però le cose che ha detto – la sostanza – e io gliele ridico parola per parola esattamente nello stesso dialetto in cui le hanno dette a me. Io non cambio niente.
[...]
Poi c’è stata Caporetto come lei saprà, coi tedeschi che hanno rotto il fronte e tutti noi a scappare davanti a loro che avanzavano: chi buttava i fucili, chi abbandonava i cannoni e chi sparava addosso ai propri ufficiali che cercavano di trattenerli. Solo alcuni però degli ufficiali. Alcuni altri si suicidarono, per il disonore. Ma la maggior parte sono scappati per primi, gli alti gradi degli stati maggiori e gli ufficiali di truppa; poi alla fine – quando è stata la fine – la colpa era solo dei soldati, e gli ufficiali si sono salvati tutti, più belli e più tronfi di prima e hanno fatto pure carriera come Badoglio, che fu tra i primi responsabili di Caporetto. I soldati che erano scappati, invece, li hanno ripresi e fucilati tutti. O meglio, tutti no. I reparti che interi s’erano dati alla fuga – i plotoni, le compagnie, i battaglioni – i carabinieri li mettevano in fila e poi contavano «Uno, due, tre, quattro, cinque: tocca a te», e quello era fatto: «Al muro!». Agli altri gli era andata bene. Decimazione si chiamava. Pure a zio Temistocle a un certo punto era preso il panico a Caporetto, perché la paura è contagiosa. Più vedi gente intorno a te che ha paura, e più ne viene pure a te, è un fatto di rassicurazione, di determinazione nel convincimento. Prima magari pensavi dubbioso: «Chissà se è il caso di avere qualche preoccupazione». Però non lo dicevi – lo tenevi per te – anche per non fare con gli altri la figura di quello che non ha coraggio. Ma appena vedi che hanno paura gli altri, allora subito ti dici: «Ah, ma qui c’è davvero da avere paura» e ti metti le gambe in spalla e via. Tu appresso agli altri e gli altri appresso a te. E così pure zio Temistocle – a vedere i tedeschi che venivano avanti come demoni, e i nostri invece indietreggiare come lepri e buttare i fucili per poter correre più forte – pure lui a un certo punto ha voltato le spalle ed è scappato. Lui però non ha buttato il fucile, non se l’è sentita. «Non si sa mai» ha pensato. E difatti gli è venuto buono dopo, quando ha trovato un gruppetto che diceva: «Dove andate, vigliacchi» e a quelli senza fucile li fucilavano lì sul posto. Ma a lui il “vigliacco” lo aveva smosso nell’orgoglio, e s’è fermato pure lui a opporre resistenza al nemico «Male che va, i me cópa» – e hanno messo in piedi un tentativo di ripiegamento ordinato. È lì che gli hanno poi dato la medaglia di bronzo, anche se lui diceva che gliel’avevano data giusto per far vedere, perché lui non è che abbia fatto atti di particolare eroismo quella volta. Lui lì s’era fermato e basta. Ce ne voleva molto di più a scattare – come aveva fatto tante volte prima, e pure dopo – dalle trincee all’arma bianca, all’assalto, a scannare tedeschi col pugnale. Lì invece – a Caporetto – fu più la gente nostra che scannò, italiani, disertori, e anche a lui toccò stare nei plotoni d’esecuzione, e ogni volta pensava che era solo per un pelo che non c’era lui, al muro, al posto di quello.
Dopo tre anni che si stava in guerra, l’Italia era ridotta allo stremo. E non solo per la fame, i viveri e tutto quanto. Oramai non c’era quasi più gente da mandare in battaglia. E allora, per tirarsi su da Caporetto, hanno dovuto chiamare alle armi anche i ragazzini, le ultime classi, il 1899, la classe di mio zio Pericle, diciotto anni: «Un putìno» diceva mia nonna, «un tosatèo».
Era un po’ cresciuto rispetto a prima, ma ancora mica tanto. Mingherlino, magrolino, biondino, aveva solo questi occhi che sembravano elettrici, occhi azzurri che non stavano mai fermi; ti guardava di qua e di là, era tutto scatti e nervoso come un’anguilla. Gli è toccato partire anche lui. E a mio nonno gli si è stretto il cuore: «Va’ in malora alla guerra e a mì che l’ho voluta».
Lui invece – zio Pericle – era tutto contento perché chissà quante volte, mentre guidava i buoi in campagna, s’era sognato a occhi aperti le scene di guerra e lui che saltava a sbaragliare il nemico. Dentro di sé, sicuramente, un po’ di paura ce l’aveva, però non la lasciava vedere, faceva il gradasso. È partito contento, allegro – o almeno pareva -coi fratelli e le sorelle ad accompagnarlo fino in fondo allo stradone, fino alla strada grande. Sono andati tutti eccetto zio Adelchi che è rimasto a casa – «Ghe xè da lavorar, qua» – sia i più grandi che i più piccoli, coi più piccoli che strillavano per farsi prendere in braccio o a cavalluccio, sulle spalle, per l’ultima volta. E quando alla fine sulla strada grande è passato uno dei carri che ogni giorno andavano verso Adria e poi a Rovigo, avanti e indietro coi bidoni del latte, zio Pericle ha fatto un segno con la mano e il conducente ha detto: «Salta su».
Allora ha dato un bacio uno per uno a fratelli e sorelle, dal più piccolo al più grande, e poi ha abbracciato la madre, mia nonna, e lei ha detto: «Torna a casa figlio, torna sano e salvo» e glielo ha detto con la voce incrinata, non piangeva, però la voce era incrinata, ne aveva due alla guerra adesso e non sapeva più se le preghiere potessero bastare, e sempre con quel pensiero fisso del prete, che non bisogna mancar loro di rispetto e che prima o poi si paga, certe cose non possono non portare male – «Sto bene io a pregare» – neanche un presentimento ma una certezza, quasi, di sciagure.
Lui invece rideva, la abbracciava e rideva: «Non state a preoccuparvi mamma, vado là, vinco la guerra e torno». Ma forse faceva solo finta di ridere. Poi ha abbracciato il nonno per ultimo, mentre il carrettiere insisteva: «Salta su, che il cavallo mi perde il passo», e non si sono detti una parola padre e figlio, solo stretti forte, evitando anche di guardarsi negli occhi, tutti e due sapendo già cosa ci fosse scritto. E poi, con un balzo, a eassetta e il carro è partito e lui ha ristrillato alla madre: «Non stì a preocuparve mama, l’erba cativa n’al more mai. Mì al torno vinsitor». E infatti è tornato vincitore.
Sono andati lui e quelli come lui – i ragazzi del ‘99 – e hanno vinto la guerra. Sì lo so che non l’hanno vinta solo loro, c’erano anche gli altri, ma allora si diceva così: «L’hanno vinta i ragazzi del ‘99». Ragazzini di diciotto anni schierati sul Piave e poi all’assalto, sotto le bombe, gli shrapnel, i gas. E si sono fatti grandi così.
[...]
Erano venuti quelli della lega contadina – i rossi, i socialisti della camera del lavoro -a dire che ogni mezzadro doveva prendersi la sua quota di braccianti, “imponibile di mano d’opera” lo chiamavano. C’era tanta disoccupazione, tanta fame, e allora quelli avevano detto: «Ogni tot di ettari di terra, ci deve stare un tot di operai a giornata e tutti i mezzadri li debbono assumere». Ora io capisco che detta così può sembrare anche giusta, perché anch’io sono d’accordo con lei che il lavoro – come la ricchezza – andrebbe diviso tra tutti quanti. Ma noi sulla terra nostra non avevamo bisogno di tutti questi operai. Chi li pagava? Va bene che eravamo a mezzadria: il padrone metteva la terra, noi il lavoro e si divideva il raccolto. Ma anche le spese andavano divise in due: le sementi, le scorte e gli eventuali operai esterni, i braccianti. Anche per questi andavano divise le spese. E chi ce li dava a noi questi soldi? Certo, quando proprio servivano un po’ di braccianti perché il lavoro era troppo o c’era fretta, pure noi li avevamo sempre presi, mica eravamo scemi. Se devi fare un raccolto e il tempo è stretto, mica ci stai a pensare sopra, chiami la gente di fuori e via. Ma un conto è che lo decido io – ovvero mia nonna – quand’è che serve davvero, un altro conto è che arrivi tu e dici: «Da oggi in poi devi mettere a lavorare in campagna Tizio e Caio». E se a me non serve? Ti chiamo a lavorare a te – e ti debbo dare pure i soldi, perché lo dice la lega – e intanto i figli miei li tengo a casa a non fare niente? E che me li sono fatti a fare allora tutti questi figli? Dov’è che li mando a lavorare? Che gli do da mangiare a loro, se lo do a te? Ho capito che bisogna dividere, ma bisogna dividere quello che si ha, non quello che non si ha. «Noi ne abbiamo a sufficienza solo per noi» aveva detto mio zio Temistocle a quelli della lega, dopo essersi consultato al volo – con lo sguardo – con la madre e i fratelli.
[...]
Come dice, scusi? perché ci chiamassero cispadani e perché soprattutto il fascio avesse dato le terre prosciugate a noi – facendoci venire dall’Altitalia – e non a loro che erano già qui? A lei pare un’ingiustizia? Lei dice che il motivo forse è che quelli di queste parti non fossero abbastanza fascisti? No, questo no. Erano fascisti come in tutta Italia. C’era il fascio locale fin dall’inizio dappertutto e s’erano fatti la marcia su Roma anche loro come tutti gli altri. Certo, pure loro prima avevano avuto i socialisti e le camere del lavoro. Ma come dappertutto, a un certo punto era cambiato il vento pure qui – oggi va di moda una cosa, domani un’altra – e tutti erano diventati fascisti. Né più né meno degli altri. Lei ha presente come ancora pochi anni fa – in tutto il Norditalia – erano tutti democristiani o comunisti e il giorno dopo tutti della Lega o berlusconiani? Se lei va a vedere uno per uno quelli che cucinano la bistecca, salsiccia e fagioli alle feste della Lega, la maggior parte li hanno già cucinati alle feste dell’Unità. Così va il mondo, che vuole da me? Innanzitutto però a noi dissero che era per ripagare il Triveneto dei danni e dolori subiti nella guerra ‘15-18. Secondopoi, quelle nostre erano le zone più povere d’Italia, i più morti di fame e disoccupati che riempivano le navi degli emigranti per le Americhe. Chiusasi quella emigrazione – là non ci volevano più, esattamente come noi oggi con gli extracomunitari – da qualche parte ci dovevano mandare. Ci hanno mandato qua. Eravamo gli extracomunitari dell’Agro Pontino. E poi però – come le ho già detto – all’Opera servivano mezzadri o coltivatori diretti, che sapessero fare tutti i lavori e che risiedessero stabilmente sul podere. Questi qui invece erano abituati a tornare ogni sera al paese loro. Chi ce li faceva restare di notte – con la paura della malaria – appresso alle bestie nella stalla? La mezzadria in Italia era praticata solo in Toscana, Umbria, Marche e Valpadana. Nel Lazio – negli Stati della chiesa -non c’era mai stata, c’era solo e sempre stato il feudalesimo e il primo in assoluto che avesse introdotto la mezzadria nelle terre sue nel Lazio, a Magliano Sabina, era stato proprio il conte Cencelli. Anche per questo, forse, il Rossoni lo aveva consigliato al Duce per l’Opera combattenti.
[...]
I miei zii oramai erano in contatto col fascio di Ferrara e quello era un periodo caldo. Alla fine di agosto – il 30 di agosto del 1920 per la precisione, anche se i miei zii non lo sapevano ancora, in quel momento, che la cosa li avrebbe potuti in qualche modo interessare – erano cominciate le occupazioni di fabbrica da parte degli operai di Torino, e poi s’erano estese a Milano. Era la Fiom, il sindacato dei metalmeccanici, che aveva messo su dei Consigli di fabbrica tali e quali ai soviet. C’era appena stata la rivoluzione in Russia e loro la volevano fare anche qui. Intanto avevano cominciato con queste occupazioni per prendersi le fabbriche e diventare loro padroni – il proletariato – e mandare i padroni a lavorare. Era pressappoco quello che volevamo anche noi sindacalisti rivoluzionari nella settimana rossa del ‘14 e loro quella volta avevano detto: «Non è possibile. Bisogna fermarsi qua» e così perdemmo. Adesso invece erano loro a dire: «Facciamo la rivoluzione, occupiamo le fabbriche» e tutto questo periodo – i due anni che vanno dal 1919 fino agli inizi del ‘21 – lei sui libri di storia lo trova proprio scritto “biennio rosso”. Scioperi, occupazioni di fabbrica, manifestazioni e violenze ogni giorno. Non s’era mai vista una cosa del genere in Italia e lo stesso senatore Agnelli – dopo che gli avevano occupato la Fiat ma anche l’Ansaldo, la Pirelli, e tutto il fior fiore dell’industria e del capitalismo italiano – s’era oramai rassegnato anche lui e aveva deciso, d’accordo coi più stretti collaboratori: «Va bene va’, non c’è più niente da fare, siamo con l’acqua alla gola. Chiamateli e mettiamoci d’accordo: io gli do la fabbrica in proprietà comune, mia e loro, e da adesso in poi la portiamo avanti insieme, io e loro». Sono stati i collaboratori a dirgli: «Senato’, la scongiuriamo, aspetti ancora qualche giorno».
«Va bene, aspettiamo ancora qualche giorno» perché ogni tanto i collaboratori bisogna pure farli contenti, anche se lui – dopo un mese d’occupazione – s’era messo l’anima in pace ed era oramai pronto a trattare: «Almeno finisce questa storia e ripigliamo a lavorare, meglio che gliela dia io in fin dei conti, prima che me la prendano loro con un calcio nel sedere; un direttore gli servirà sempre». Ma anche questa volta – tale e quale alla settimana rossa del ‘14 -chiacchiere e basta, altro che rivoluzione. Tanto è vero che neanche dopo un mese – alla fine di settembre – in cima alle fabbriche di Milano e di Torino hanno tolto le bandiere rosse con la falce e martello dei Consigli di fabbrica, i nuovi soviet, e hanno fatto tornare buoni buoni gli operai a lavorare sotto gli stessi padroni, agli ordini degli stessi identici capi. E non solo senza avere fatto la rivoluzione o preso il potere, ma alle stesse identiche condizioni di prima. Anzi, i capi erano pure più boriosi e i collaboratori più stretti del senatore Agnelli sono andati poi avanti anni a rinfacciargli: «Ah, se non c’eravamo noi quella volta! Se era per lei avevamo perso tutto». Tanto che alla fine gli ha dovuto dire: «E mo’ basta! Il prossimo che lo dice un’altra volta lo caccio sui due piedi». Ora però anche un bambino sa che se chiami in continuazione la gente alla lotta senza fargli mai ottenere risultati tangibili, quelli alla lunga ti mollano e non ti ascoltano più: «Al lupo, al lupo». Anzi, più li hai fatti lottare senza un costrutto, e più a quelli gli passa la voglia di rilottare un’altra volta: «Ma che sono scemo? Vado a ripigliare le bastonate gratis?». E comunque quel biennio rosso è andato avanti tutto il 1920 – dal 1919 che era iniziato – fino al 1921, che è stato pure peggio perché è arrivato il “riflusso” delle lotte, come lo chiamava Lenin (lei non so se lo sa che il Lenin e Mussolini s’erano conosciuti in Svizzera prima della guerra -esuli squattrinati tutti e due – nel 1903 o ‘4. Si incontravano in giro per Losanna, che era piena di rivoluzionari che ogni volta per la strada si chiedevano l’un l’altro: «Ghètu un franco da prestarne?». Adesso non so se ci fosse anche il Lenin quando Mussolini sfidò Dio – «Vieni qua e fulminami» – con l’orologio in mano. Comunque nel 1917 quello fece la rivoluzione in Russia e prese il potere, e Mussolini leggendolo sul giornale disse: «Va’ il Lenin va’, son contento par lù». Quando invece nel 1922 ha fatto la marcia su Roma ed è andato su lui, il Lenin disse proprio a Stalin: «Va’ il Mussolini, va’! L’avevo sempre detto io, che l’unico rivoluzionario in Italia era lui». Ed era tutto incazzato con la sinistra nostra italiana che se lo era fatto scappare). Ma oltre al riflusso loro c’è stata la reazione nostra, e oramai era lotta a coltello, con sparatorie, incendi, morti e feriti. Rossi di qua e neri di là. E noi stavamo con i neri – anzi, eravamo i neri – e una volta anche i miei zii sono tornati con zio Pericle, steso sul pianale del carro.
[...]
Noi però oramai stavamo col fascio di Ferrara, dipendevamo da lì. E a Ferrara comandava Italo Balbo. Il Rossoni invece stava a Milano a dirigere i sindacati fascisti e con il Balbo non si è mai potuto pigliare. Il Balbo era uno che, dove c’era lui, doveva comandare tutto lui. Anche al Mussolini – fino all’ultimo – gli ha sempre detto: «Tu comandi su tutto e io obbedisco. Ma nel poco che mi dai da comandare a me, ci comando solo io e neanche tu ci metti bocca». E difatti anche col Mussolini – pure dopo che è diventato Duce – non è che ci si sia mai tanto preso. Il Duce alla fine non lo poteva proprio più vedere, perché era l’unico che anche in Gran Consiglio continuava a dargli del tu. A quello gli rodeva. Gli sembrava che non rispettasse il grado e lo ha mandato in Libia: «Va a fare il Governatore là, fora dai piè». Anzi, si dice che – ma i miei zii non ci credevano e neanche io ci credo – fosse stato lui a dare l’ordine alla contraerea di sparare, altro che sbaglio, quella volta che Balbo tornava da un volo sull’Egitto. Era appena scoppiata la Seconda guerra mondiale e dalla San Giorgio – una nave da battaglia che era stata interrata apposta, per proteggere meglio la piazzaforte di Tobruk – vedendo questo apparecchio che arrivava, si sono creduti che era un apparecchio inglese e allora via tutti a sparare Fino a che non lo hanno preso ed è caduto giù. E subito i marinai a tirare i berretti in aria per la contentezza: «O ghémo ciapà, o ghémo ciapà», perché pare che poi la San Giorgio non ne abbia più preso uno solo di apparecchio nemico. Né prima né dopo. Tutti passavano e non gli succedeva niente – l’antitriangolo delle Bermude – e s’era sparsa la voce tra i piloti britannici: «Passiamo sulla San Giorgio che lì non ci prendono neanche se viene giù Cristo». Solo quello hanno preso d’apparecchio in vita loro. E non gli pareva vero. Poi però, quando sono andati a vedere, era il Balbo; avevano buttato giù lui, i lo ghéva copà. E la gente in Italia diceva che non era stato un errore – era stato un tradimento – perché il Duce era geloso e aveva paura che il Balbo gli levasse il posto. Queste sono tutte chiacchiere naturalmente, ciàcole dicevano i miei zii, anche se adesso s’è scoperto che quel giorno in rada c’era pure lo Scirè – un sommergibile famoso per le operazioni speciali supersegrete – e aveva sparato pure lui senza dire niente a nessuno. Era arrivato la sera prima ed è ripartito il giorno stesso, neanche un’oretta dopo che l’aereo del Balbo era stato abbattuto. Poi faccia lei; però rimane il fatto che quello, il Balbo, era un grande organizzatore, una macchina piena d’energia e fu lui che nel 1924 – quando oramai Mussolini stava nel pallone per il caso Matteotti – fu lui che gli diede la scossa e lo resuscitò come Lazzaro. O Frankenstein. Tutti lo attaccavano in parlamento oramai. Era rimasto solo come un cane, aveva poche ore – dicevano tutti quan ti – si doveva dimettere perché il caso Matteotti era trop po grosso ed era lui il mandante. O meglio, lui diceva che non era vero e lo dicevano anche i miei zii: «È stato il Dumini che ha sbagliato tutto». Ora però sarà pure vero che forse ha sbagliato il Dumini e che loro non volessero uccidere, gli volevano solo dare una lezione e basta al Matteotti che il 30 di maggio del 1924, in parlamento, a Mussolini gliene aveva dette di tutti i colori. Lo aveva fatto diventare una bestia, tanto che appena uscito dal parlamento – proprio lì sul portone dell’aula, rosso di brace, tutto infuriato e fumante – Mussolini aveva urlato a Cesarino Rossi, il segretario particolare suo che sapeva vita morte e miracoli e ogni più piccolo impiccio suo: «Che fa il Dumini?». Ed era incazzato nero. Questa è storia. Loro il Dumini a Roma ce lo tenevano apposta – pagato e stipendiato dal Viminale con tutta la squadraccia sua, la “Cèka nera” come la chiamavano – proprio per questo tipo di evenienze. Così quando il Cesarino Rossi è andato dal Dumini a ridirgli: «Ma che cosa ci stai a fare tu? A mangiare e bere a tradimento? Che stai ad aspettare? Che fa il Dumini! ha detto il Duce» quello ha capito al volo e ha chiamato tre o quattro dei suoi. Sono partiti con la macchina. Hanno preso il Matteotti al Lungotevere. Lui non voleva salire. S’è difeso. Quelli hanno cominciato a menare. Lo hanno caricato a forza. Ma lui si difendeva pure in macchina. E quelli hanno rimenato più forte. Erano partiti per dargli solo una lezione – almeno così hanno detto – ma a un certo punto hanno tirato fuori un pugnale e una lima e lo hanno ammazzato a coltellate. S’erano portati appresso i pugnali. Poi lo hanno nascosto e sotterrato in un bosco. È stato ritrovato – il povero Matteotti – solo due mesi dopo, il 16 di agosto, e Mussolini era di nuovo incazzato: «Ma che avete fatto?».
«Ma me lo hai detto tu» gli rispondeva il Cesarino Rossi: «Che fa il Dumini?».
Allora – nel 1924 – il Mussolini dipendeva ancora dal parlamento e il parlamento lo ha messo in croce. Era additato per tutta Italia come un assassino, un presidente del consiglio parlamentare che se un deputato gli ha parlato contro, gli manda i mazzieri e gli assassini sotto casa. Tutta la nazione scandalizzata lo stava lasciando solo. Tutti sull’Aventino. Tutti i giornali a dire: «Il caso Matteotti di qua, il caso Matteotti di là». E anche un
sacco di fascisti se ne stava andando e anche un sacco di gente che s’era messa dalla parte sua ma che adesso – vedendo la mala parata – si rivoltava già da un’altra parte: «Eh no, queste cose non si fanno», come se prima non lo avessero saputo che al potere c’era arrivato così, con le schioppettate, e da che mondo è mondo funziona così, il potere mica è pulito, diceva mia nonna. Se tu sei pulito, al potere non ci vai, fai un altro mestiere, non ti metti a cercare il potere. Guardi anche adesso: ma secondo lei Pecorelli si è suicidato? A quello gli hanno sparato. È vero che la magistratura ha detto che erano tutti innocenti – Andreotti e Vitalone – ma quello mica si è suicidato. Il potere funziona così, e finché stai in sella, tutti dicono che tu non c’entri niente, che ti hanno solo messo in mezzo; anzi, sono tutte calunnie inventate dai tuoi nemici per screditarti. Ma se poco poco fai la finta di scivolare, tutti quelli che prima facevano finta di niente adesso dicono subito: «Eh no, queste cose non si fanno», e sono i primi loro adesso a darti addosso.
E così era per il Mussolini alla fine del 1924. Solo come un cane. Gli ultimi giorni dell’anno girava come un matto per tutte le stanze della presidenza del consiglio. Girava per i corridoi bianco come un lenzuolo e gli uscieri si aspettavano da un momento all’altro di sentire un colpo di pistola dalla sua stanza, quando restava da solo. È stato così – tra Natale e san Silvestro, mentre lui stava in balìa tra la vita e la morte, tra la fuga e la resa – che Italo Balbo s’è presentato all’improvviso alla presidenza del consiglio insieme a un gruppetto di altri ras, messi insieme da lui, e gli ha detto a brutto muso: «Adesso basta, devi reagire. E se non lo fai tu con le buone o le cattive, lo faccio io e me lo prendo io il potere». Lui era ancora titubante, pareva un ragazzino: «Ma l’opposizione…». «L’opposizione una mona!» lo ha strapazzato il Balbo: «Per cosa lo abbiamo preso a fare il potere allora, per ridarglielo indietro alla prima occasione?». E lui si è fatto coraggio. Si è tirato su con le spalle — pure per non far vedere agli altri ras che aveva paura del Balbo – e un paio di giorni dopo, il 3 gennaio del 1925, ha fatto il discorso alla camera dove ha detto: «Adesso basta, mi assumo io la responsabilità del caso Matteotti, ma chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori: sciolgo i partiti, chiudo i giornali e faccio le leggi eccezionali. Da inquò, da oggi, la democrazia è finita in Italia, comandi solo mè. Xè ditatura».
[...]
Comunque il Rossoni ha detto: «Sentite Peruzzi… per arrivare al potere e cambiare qualche cosa, dobbiamo fare i patti anche col diavolo, anche col re. Pure il Papa se serve. Poi dopo, arrivati al potere, ribaltiamo tutto e ci pigliamo le terre, facciamo una seconda ondata. Ma prima dobbiamo arrivare nella stanza dei bottoni».
«La stansa d’i boton?» ha fatto zio Pericle pensando lì per lì a una cosa pressappoco come quando le sorelle si riunivano nella stessa stanza tutte insieme, a riattaccare i bottoni caduti da braghe e camicie. Poi ci ha pensato e ha detto: «Va bèn Rossoni, rivémo int’la stansa d’i boton». Questa stanza dei bottoni non era per la verità una pensata tutta nostra, dei fascisti o del Mussolini. Era di un amico suo – Pietro Nenni, romagnolo come lui – che si conoscevano da giovani quando erano rossi. Anzi, il Mussolini era rosso, socialista e rivoluzionario. Il Nenni invece – quando si sono conosciuti e sono andati la prima volta in galera assieme – era ancora repubblicano. Poi erano stati interventisti assieme ed è dopo la guerra, coi fasci di combattimento, che si sono divisi. Pietro Nenni nel ‘21 diventò socialista e poi è stato anche segretario ed è stato lui che nel 1963 – sessantanni dopo che lo aveva detto Giolitti – è riuscito a portare i socialisti al governo con la Dc, e ancora andava dicendo: «Adesso sì che entriamo nella stanza dei bottoni». «Ma cos’èia, Pierìn, questa stansa d’i boton?» lo prendeva in giro il Mussolini quando ancora stavano in prigione assieme: «A me mi servirebbe proprio un bottone nuovo» faceva mostrando la camicia sporca e sbrindellata. Per il Nenni il potere era la stanza dei bottoni, una camera dove tu entravi – al palazzo del governo o dal re – e c’era un tavolo grande con tutti i bottoni e tu ne schiacciavi uno e partivano automaticamente gli ordini. C’era il bottone delle banche, quello dei negozi, l’esercito, le guardie, la marina, le fabbriche, le centrali elettriche. Per ogni cosa c’era un bottone che diceva sì o no, bastava schiacciarlo e il treno del Paese andava di qua o veniva di là. «Tutto sta ad entrarci, nella stanza dei bottoni» diceva il Nenni, «poi li schiacci e li manovri e si fa quello che dici tu.» Lui c’è entrato nel 1963. Mussolini invece lo ha anticipato e ci è entrato nel 1922. Poi quello che ci abbiano trovato – dentro quella stanza dei bottoni – lo sanno solo loro. Comunque i miei zii hanno creduto al Rossoni – si sono fatti convinti – perché era convinto per primo lui che fosse quella la strada più giusta per ottenere il riscatto e la giustizia sociale che sognavamo da sempre: «Sapessi tu, a me, come mi sta sullo stomaco quel Balbo, con i suoi agrari e quella sua barbetta da cavrìn». E così finalmente nel 1922 – con la marcia su Roma – siamo entrati nella stanza dei bottoni. «Maestà» gli ha detto il Mussolini al re: «Vi porto l’Italia di Vittorio Veneto» che voleva dire che erano tutti i combattenti – il proletariato contadino che aveva fatto e vinto la guerra – e stavano tutti dietro di lui. A Vittorio Veneto era stata vinta l’ultima battaglia prima dell’armistizio con gli austriaci il 4 novembre 1918. “I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Firmato Diaz” c’era scritto sul bollettino della vittoria che stava oramai attaccato dappertutto, e lei non ha idea di quanta gente in quegli anni, poi, quando gli nasceva un figlio correva subito all’anagrafe: «Firmato! Questo qua lo ciamémo Firmato come il Diaz». Era pieno di Firmati in giro. I miei zii invece – quando magari all’osteria avevano appena detto chissà cosa d’importante – ogni tanto concludevano anche loro: «Firmato Peruzzi!», assestando un bel pugno sul tavolo. Ma anche quando calavano l’asso. Specie mio nonno: «Firmato Peruzzi!».
[...]
E invece questo canchero – a mezzanotte passata, con tutto quel che c’era da fare l’indomani – le si era infilato dietro. «Ma mì lo cópo» e già aveva preso con la mano il coltello grosso del pane. Zio Pericle di là dal tavolo – lei stava di qua, davanti alla tenda che copriva l’ingresso dello sgabuzzino – le ha ridetto piano, perché nessuno sentisse dalle altre stanze: «Agò da parlarte».
«Va’ via! N’agò gnènte da dirte!» ha sibilato piano piano pure lei.
«Ma agò da dirtelo mì» ha insistito zio Pericle quasi pregando, e intanto superava il tavolo e le si avvicinava.
«Va’ via!», ha detto più forte lei minacciandolo con il coltello.
Lui le ha messo una mano sulla bocca – per tappargliela – e con l’altra l’ha stretta forte per un braccio tirandola a sé: «Agò copà un cristiàn, un prete! maladéto mì», e appena finito di dire «maladéto mì» è scoppiato a piangere. E s’è nascosto il viso tra le mani.
In quel mentre – attratto da quell’abbozzo d’urlo della ragazza – s’è affacciato alla porta della cucina un parente del morto, un cugino, che appena ha visto di spalle mio zio singhiozzare ha pensato: «Ma guarda tu quanto bene che gli voleva il Pericle a mio cugino. Chi lo avrebbe mai detto?». Lei subito gli ha fatto segno tranquilla con la mano: «Vai, vai, ci penso io» e quello se ne è andato.
Neanche hanno chiuso la porta. Lei gli ha solo toccato le mani per scostargliele dal viso, per farlo smettere di piangere. Ma appena c’è stato il contatto c’è stata la scossa. Non ha capito più niente nessuno dei due. Mio zio ha rivisto per un attimo il prete e subito ha risentito il «Toc» sordo del cranio che si rompeva sotto il suo bastone e i rantoli e il cattivo odore che subitaneo s’era emanato dallo sfintere non più sotto controllo. L’Armida anche lei ha risentito gli odori del morto suo e il capo che – rivestendolo – senza più vita ondeggiava di qui e di là ad ogni movimento ed il calore che man mano se ne andava, e si faceva gelido, quell’uomo che ancora a pranzo era nel pieno delle forze e la pigliava in giro. E mentre dal corridoio giungeva sommesso il coro delle litanie
Santa Maria. Ora pro nobis.
Santa Dei Genetrix. Ora pro nobis.
Santa Virgo Virginum. Ora pro nobis.
loro si sono buttati oltre la tenda dello sgabuzzino tenendosi strette le braccia. Lei con la mano, da dietro, s’è solo sincerata che la tenda – un cotone sdrucito e rammendato più volte anche da lei stessa – non si fosse per caso impigliata nella madia, senza richiudersi a dovere. E si sono presi con furia, in piedi, appoggiati alla parete di fianco allo scaffale delle bottiglie di pomodoro.
Mater Divinae Gratiae. Ora pro nobis.
Mater Purissima. Ora pro nobis.
Mater Castissima. Ora pro nobis.
continuava il coro delle litanie, con le voci flebili in falsetto delle donne e i toni bassi e forti delle voci maschili
Turris Eburnea. Ora pro nobis.
Ianua Coeli. Ora pro nobis.
mentre zio Pericle le diceva: «Spèteme!» pensando a tutti gli anni di carcere. «Aspettami, Armida, non posso più star sènsa tì.»
E lei ansimando «At spèto, at spèto», rispondeva a ogni colpo andandogli ogni volta più forte incontro: «At spèto par sempre, maladéta mì».
E quando hanno finito – «Amen» diceva intanto il coro -mio zio s’è sentito svuotarsi l’anima, entrare tutta dentro di lei e poi tornare nuova e mondata in lui. E allora ha pensato: «Oggi ho generato dentro di te tutti i miei figli e le mie generazioni». Ma non lo ha detto, perché aveva paura di quel che aveva pensato.
Pure lei però – pure l’Armida – quando lui s’era svuotato, aveva sentito entrare in sé il fiume sacro delle sue generazioni: «Oggi ho concepito dentro di me come le mie api tutti i tuoi figli, che conserverò gelosamente e metterò uno per uno, come le mie api, quando sarà l’ora al mondo».
Poi zio Pericle ha detto: «Spèteme al ponte», ha salutato i vivi e il morto, è uscito ed è andato lì e da allora in poi - per tutta la vita - ogni tanto la sera lei, girata dall’altra parte per dormire dopo avere fatto l’amore, gli ha chiesto dubbiosa nel buio: «Ma se ti dicevo di no quella volta, tu che facevi?». E lui immancabilmente duro: «At còpavo anca tì». Lei gli risaltava addosso, e rifacevano l’amore.
[...]
Erano le zanzare il maggiore pericolo e questo all’Opera – ma anche le maestre a scuola – non facevano che ripeterlo: era lei che pungendoti trasmetteva la malaria. Come dice, scusi? No, no, non si trattava delle zanzare normali che si vedono in giro ancora adesso. Era la zanzara anofele ed era un po’ più grossa, ma non era lei che faceva nascere dentro di sé il bacillo della malaria. Lei quando nasceva era sana. Era solo portatrice e il bacillo lo pigliava andando a succhiare il sangue ai cristiani già ammalati. Quando poi riandava a mordere i sani, l’attaccava a loro. Nelle Paludi Pontine era pieno di gente ammalata. Pure da noi in Valpadana c’era un po’ di malaria, ma non come qui, qui era un’ira di Dio e c’erano tutti i tipi della malattia, non solo quella più endemica, normale, che t’ammazzava piano piano con grandi febbroni periodici e con l’avvelenamento del fegato, l’epatite. Il fegato man mano s’ingrossava e vedevi tutta questa gente qua – e anche i pastori ciociari e abruzzesi e i butteri cavallari di Cisterna – con la pancia grossa grossa. Gonfia. “Panzarotti” li chiamavano, e poco a poco morivano. Ci si curava con il chinino. Passavano i cursori della Croce Rossa a cavallo a distribuirlo in pasticchette, che pigliavamo pure come misura preventiva. In ogni borgo c’erano le dispense, dove appunto «dispensavano» il chinino e dove vendevano anche i sali e tabacchi, perché allora il chinino, il sale e il tabacco erano tutti e tre privative dello Stato. Poi i primi commercianti ci hanno messo anche i generi alimentari, la pasta, l’olio di semi e poi la mescita del vino, l’osteria, il gioco delle bocce e così ancora adesso – che sono cinquant’anni che non s’è più visto un malarico o una pastiglia di chinino – da noi le botteghe d’alimentari continuano a chiamarsi “dispense”. Erano veri e propri general store come i saloon della conquista del West. Lei ci poteva trovare pure le vanghe e i chiodi, se le servivano.
C’erano però anche le forme più pericolose di malaria -la perniciosa o la terzana – che erano capaci d’ammazzarti nel giro di quarantotto ore, con febbri improvvise di oltre quarantadue gradi.
Non c’era il Ddt allora, non c’era niente. Dovevi solo corrergli appresso con la paletta alle zanzare. O meglio: c’erano i pipistrelli – grandi torrette di legno piene di buchi rotondi, messe un po’ qua e un po’ là per tutta la palude in via di bonificazione – in cui i pipistrelli facevano il nido. Ce li avevano portati da tutt’Italia perché il pipistrello è ghiotto di zanzare e le prende al volo meglio di un caccia intercettore. Un F-16. Alle donne facevano un po’ schifo – non è tanto bello il pipistrello, diciamo la verità, e se ti si attacca ai capelli non si stacca più – ma appena hanno cominciato a impiantarsi da soli i nuovi nidi sotto le cantinelle dei cornicioni dei poderi o sulle capriate d’ogni stalla, la gente gli ha fatto gli altarini, gli ha steso i tappeti all’ingresso e li trattava meglio dei bambini in fasce. Le donne mancava poco gli portassero il latte coi biscotti e se solo ti vedevano con la mazzafionda in mano davanti alla stalla – il pomeriggio, quando loro dormono attaccati in fila a testa in giù nell’angolo più buio della capriata – ti schiacciavano di botte più che a una zanzara. È un animale sacro in Agro Pontino e guai ancora adesso a fargli torto.
Però non era Dio, il pipistrello. Da solo non ce la poteva fare in questo universo di zanzare anofeli. L’unico modo per batterle era sterminare dentro l’acquitrino i figli prima che nascessero. Era quella la cerniera del fatale trinomio «anofele-acquitrino-uomo malarico», perché l’anofele – quando fa le uova – le deposita sul filo umido e caldo dell’acqua stagnante, tra dentro e fuori. Ma deve essere acqua ferma, non corrente, se no le uova se le porta via e arrivederci e grazie. Lì l’ovetto si fa tutto il suo percorso di larva e quando è ora rompe il guscio, sale a galla, si dà un scrollatina alle alucce, comincia a svolazzare e il primo cristiano che incontra – malarico o non malarico – si mette a mozzicare a rotta di collo, succhiando e alfin mischiando i sangui.
Per questo bisognava fare la bonifica e asciugare ogni pozza, ogni stagno, ogni padule e scavare canali. Solo acqua corrente doveva esserci, neanche più un bicchiere lasciato all’aperto con una goccia d’acqua ferma. Era peccato mortale – quando siamo arrivati – dimenticarsi per caso un secchio o una bacinella la sera con un po’ d’acqua all’aperto. Ti rimpacchettavano – l’Opera controllava tutto, i fattori facevano avanti e indietro a ogni ora del giorno e della notte, il nostro pretendeva che spazzassimo pure il fondo delle scoline in fianco alla strada, non gli bastava che ne falciassimo l’erba – ti rimpacchettavano e spedivano indietro con tutta la famiglia. Altroché l’ecocidio di cui parlano alcuni, per i quali la palude sarebbe stata un ecosistema che avremmo dovuto ad ogni costo proteggere. E sì, no? Mo’ proteggevamo le zanzare e la malaria?
Come dice, scusi? che così però non vengono più neanche le poiane e gli altri uccelli migratori? Ma che vada in malora anche lei e le poiane. Adesso una poiana ha più diritto a vivere di me? Io vorrei vedere lei al posto nostro, se ci stava lei nelle Paludi Pontine con la malaria. Perché non se le alleva dentro casa sua le zanzare?
Comunque la bonifica non è che si sia fatta dalla sera alla mattina. Ci sono voluti dieci anni per prosciugare e sistemare tutto, da Cisterna a Terracina e dai monti al mare. Bonificavamo un pezzo alla volta e neanche tanto piano piano, ma proprio di corsa. E mentre già c’erano i coloni dentro i poderi nelle aree bonificate, contemporaneamente a valle c’era ancora la palude melmosa e tu correvi il rischio che gli operai – che stavano appunto a scavare i nuovi canali -ti morissero di malaria per le zanzare ancora vive e vegete nel
padule superstite. Nemmeno si sa con precisione quanti siano stati i morti per malaria durante i lavori e tanto meno quanti – presa la malaria qui – se ne siano poi tornati a morire a casa loro in Toscana da dove erano partiti, o anche dalla Calabria, Ciociaria, Sicilia, Bergamasca e tutta Italia.
Più di centocinquantamila furono gli operai impiegati da Opera e Consorzi, e non meno del dieci per cento – quindici o ventimila – debbono essere morti per malaria. Si davano il cambio, facevano un periodo di lavoro e poi subito scappavano con la poca paga a casa loro. E poi Dio vede e provvede. Quelli che invece – «Zac!» – li pigliava all’improvviso la terzana e restavano la mattina in baracca stesi sopra il letto a saltare con la febbre a quaranta, quelli li caricavano su una lettiga e via di corsa a morire a Velletri, in ospedale, perché non risultassero morti di malaria in palude. “Meningite” o “infarto”, scrivevano poi sui certificati di morte, e “Velletri”, non “in palude”, perché il fascio «la malaria l’aveva debellata». Ma che debelli, se poi invece la gente ci muore?
Quelli morivano a Velletri mentre a noi – sugli acquitrini – il fascio faceva spandere manti di carburo misto a sabbia e polvere di strada. Il manto polveroso restava per un po’ a galla e l’anofele – quando cercava di deporre le uova sull’acquitrino – non riusciva a penetrarlo e rimaneva fregata, le uova restavano a seccarsi nella polvere e addio figli. Ma non era con la polvere di strada che potevi debellare la malaria. Era poca roba. Funzionava un giorno o due. In America ci buttavano il petrolio. E quello sì che funzionava. Ma loro il petrolio ce lo avevano. Noi no, noi neanche per accenderci i lumi, si figuri per buttarlo sugli stagni. E la lotta contro le zanzare e la malaria l’abbiamo fatta con la polvere di strada, i pipistrellai, un po’ di «flit» – una specie di insetticida che spruzzavamo con la pompa a mano e un barattoletto attaccato in fondo; ma era più un ricostituente, una Ferrochina Bisleri, per le zanzare che ne andavano ghiotte e ci si ingrassavano come maiali – e soprattutto le carte moschicide che tutte nere pendevano dai soffitti. Oltre naturalmente alle
palette di fil di ferro e alle ciabatte per schiacciare al muro le zanzare, quando le trovavi.
Questa è stata in Agro Pontino la lotta antimalarica fino a tutti gli anni Quaranta e i primi Cinquanta – quando continuavamo ancora ogni tanto a prendere la malaria – finché non è arrivata la Seconda guerra mondiale con gli americani. Allora sì che è davvero finita la malaria, perché se al resto d’Italia hanno portato come si suole dire libertà e democrazia, a noi – che di libertà non ne avevamo mai vista e masticata tanta neanche prima del fascismo, anzi pure peggio – a noi gli americani hanno portato soprattutto il Ddt. Loro lo avevano appena inventato e non lo avevano ancora sperimentato su larga scala. Così quando sono arrivati qui hanno detto: «Provémolo qua!». Hanno riempito un paio di Dakota – certi apparecchioni loro – con tutti questi bidoni di Ddt e avanti e indietro per l’Agro Pontino finché non lo hanno allagato tutto quanto di Ddt. L’esperimento è riuscito – «Orca, se l’è riusìto!» deve avere detto a Truman il generale suo – e non s’è più vista una zanzara anofele in tutto il Lazio e neanche s’è più visto un ammalato di malaria, nemmeno a pagarlo oro. A Velletri hanno dovuto chiudere il reparto. Così gli americani – verificato che a noi cristiani non avesse fatto niente, perché il Ddt sarà anche non-biodegradabile ma sull’uomo non ha alcun effetto negativo; forse, chissà, ce l’ha positivo – gli americani ci si sono tranquillamente andati a disinfestare tutte le paludi loro: «Testato in Agro Pontino» hanno detto. Adesso il Ddt è vietato in tutto il mondo. Perché non è biodegradabile. Resta nel ciclo alimentare e non si dissolve più. Lo hanno trovato perfino nel tessuto adiposo delle foche al Polo Nord. Allora hanno detto: «Basta col Ddt, non si può più fare». Ma a noi ci ha salvati dalla malaria e se non era per il Ddt, noi non ci vivevamo in cinquecentomila su questo territorio.
[...]
Come dice, scusi? perché ci chiamassero cispadani e perché soprattutto il fascio avesse dato le terre prosciugate a noi – facendoci venire dall’Altitalia – e non a loro che erano già qui? A lei pare un’ingiustizia? Lei dice che il motivo forse è che quelli di queste parti non fossero abbastanza fascisti?
No, questo no. Erano fascisti come in tutta Italia. C’era il fascio locale fin dall’inizio dappertutto e s’erano fatti la marcia su Roma anche loro come tutti gli altri. Certo, pure loro prima avevano avuto i socialisti e le camere del lavoro. Ma come dappertutto, a un certo punto era cambiato il vento pure qui – oggi va di moda una cosa, domani un’altra – e tutti erano diventati fascisti. Né più né meno degli altri. Lei ha presente come ancora pochi anni fa – in tutto il Norditalia – erano tutti democristiani o comunisti e il giorno dopo tutti della Lega o berlusconiani? Se lei va a vedere uno per uno quelli che cucinano la bistecca, salsiccia e fagioli alle feste della Lega, la maggior parte li hanno già cucinati alle feste dell’Unità. Così va il mondo, che vuole da me?
Innanzitutto però a noi dissero che era per ripagare il Triveneto dei danni e dolori subiti nella guerra ‘15-18. Secondopoi, quelle nostre erano le zone più povere d’Italia, i più morti di fame e disoccupati che riempivano le navi degli emigranti per le Americhe. Chiusasi quella emigrazione – là non ci volevano più, esattamente come noi oggi con gli extracomunitari – da qualche parte ci dovevano mandare. Ci hanno mandato qua. Eravamo gli extracomunitari dell’Agro Pontino. E poi però – come le ho già detto – all’Opera servivano mezzadri o coltivatori diretti, che sapessero fare tutti i lavori e che risiedessero stabilmente sul podere. Questi qui invece erano abituati a tornare ogni sera al paese loro. Chi ce li faceva restare di notte – con la paura della malaria – appresso alle bestie nella stalla? La mezzadria in Italia era praticata solo in Toscana, Umbria, Marche e Valpadana. Nel Lazio – negli Stati della chiesa -non c’era mai stata, c’era solo e sempre stato il feudalesimo e il primo in assoluto che avesse introdotto la mezzadria nelle terre sue nel Lazio, a Magliano Sabina, era stato proprio il conte Cencelli. Anche per questo, forse, il Rossoni lo aveva consigliato al Duce per l’Opera combattenti. Ora però è anche evidente – come dice giustamente lei -che qui prima di noi non è che non ci fosse proprio mai stato nessuno. Le Paludi Pontine erano un inferno – un deserto paludoso-malarico – però ci stava pure qualcuno qua sopra, prima di noi. E questa è la verità. C’erano innanzitutto i cisternesi – i butteri – che a cavallo proprio come i cowboy andavano appresso al bestiame del principe Caetani o delle altre famiglie nobili romane, i Borghese, i Colonna, gli Annibaldi. Era tutto loro qua, tutto dei nobili e soprattutto dei Caetani. C’era però anche gente dei monti Lepini in palude. Questi in realtà – per la maggior parte – il mangiare se lo procuravano lassù in montagna. Quelli di Cori il grano lo piantavano a Tirinzania e fin sul monte Lupone. A Sezze idem: il frumento per tutto l’anno se lo facevano in montagna, ai Casali e nelle Valli di Suso, che vuol dire proprio «valli di sopra», sopra al paese. Non di sotto. Di sotto, in palude, ci venivano solo i morti di fame, i ricchi no – e neanche quelli non ricchi ma non proprio proprio disperati – a contendersi appunto fame e morte con la palude e la malaria. Però qualcuno ci veniva; a caccia di ranocchie, alla pesca di frodo nelle piscine, a provare a coltivarsi un campicello nascosto da qualche parte. E poi a raccogliere il legnatico e allevarsi qualche porco. I bassianesi – quelli di Bassiano – vantavano un diritto di proprietà secolare collettivo, chiamato università agraria, su parecchie terre della duna quaternaria, nella zona dove adesso c’è Borgo San Donato. Qui diverse famiglie -anche qualche centinaio di persone – risiedevano nei mesi freschi dentro le lestre, che erano gruppi di capanne pressappoco come i casoni nostri del Veneto, fatte di pali, rami, legni, canne ed erbe palustri. E qua i bassianesi ci piantavano il granturco. Ma soprattutto il guadagno loro – sempre se si può dire guadagno, perché non è che fosse proprio un pozzo di petrolio – le popolazioni dei monti Lepini lo facevano coi pecorai che ogni anno calavano dai monti della Ciociaria e dell’Abruzzo. Era la transumanza verticale. I pastori d’estate tenevano le greggi a pascolare in montagna, in altura, e a metà settembre le guidavano a valle: «Settembre, andiamo. È tempo di migrare./Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori / lascian gli stazzi e vanno verso il mare». Alla fine dell’inverno poi – quando in palude ricominciava a fiorire la zanzara anofele e sui monti, invece, iniziava il disgelo, le nevi si scioglievano e rifiorivano i nuovi e freschi pascoli – pecore e pastori ritornavano su: «Ci rivediamo a settembre». C’è ancora oggi – ad attraversare la piana dell’Agro Pontino dai monti fino alla duna quaternaria – una strada che si chiama appunto “strada dei Bassianesi” ed è quella che percorrevano i pastori nella loro transumanza dalla Ciociaria e dall’Appennino a qui e su cui si metteva, armata, la guardia dei Bassianesi a fargli pagare uno per uno ingresso, passaggio e pascolo di pecore e cristiani.
[...]
Quello che più colpì mio zio Adelchi di Addis Abeba quando vi entrò per la prima volta alla testa delle truppe vittoriose subito dietro al maresciallo Badoglio, furono gli eucalypti. «Varda i calìps» disse al suo amico e compare Franchini di Cisterna che marciava al fianco suo – a passo romano e moschetto spall’arm – nell’ultima fila in fondo del plotone d’onore della compagnia Camicie nere “Littoria”, subito dietro alla bandiera di combattimento: «Varda i calìps come ch’i vièn!». Era il 5 maggio 1936 e loro stavano nell’ultima fila perché erano i più alti. «Zitto e marcia, compa’» gli rispondeva però Franchini, «che qua ci puniscono un’altra volta.»
«Ma guarda i calìps come sono grandi, Franchìn! Varda che bestie ch’i vièn.» Bestie appunto da quaranta metri d’altezza. Con dei tronchi che non ce la facevano due uomini grandi ad abbracciarli, e mio zio e il compare Franchini ci si provarono pure. Era tutto un bosco d’eucalypti Addis Abeba, una macchia scura in cui si nascondevano tra i tronchi le abitazioni e da cui emergevano in altezza – fra i rami e le fronde – solo i tetti e le coperture in lamiera dei palazzi più grandi e degli edifici pubblici.
Mai visti prima, ripeto, eucalypti così, perché da noi -appena arrivati – non erano che piantine d’un metro, messe a dimora il giorno prima. Anche i miei zii erano andati a piantarli per conto dell’Opera nei mesi invernali – pagati a giornata per integrare il reddito – lungo tutte le strade, fossi e canali. I primi furono proprio quelli in cima all’argine del Canale Mussolini, piante piccoline appunto, che facevano anche pena a vedersi, fragili e striminzite, con questi filini di foglie allungate come spine di pesce: «Ma sono foglie queste? Sono alberi?». Poi arrivi ad Addis Abeba e trovi queste bestie. «Orca!» aveva detto mio zio Adelchi.
Lì ce le aveva fatte mettere nel 1896 l’imperatore Menelik II Negus d’Etiopia – subito dopo averci sconfitto ad Adua - perché i ginepri che c’erano prima s’erano seccati. «Qua non ci cresce più niente» pare gli avessero detto i tecnici nostri qualche anno prima, quando ancora andavamo d’amore e d’accordo. Poi invece avevamo cambiato idea rispetto all’amore e all’accordo, lo volevamo tutto noi l’impero suo. Allora lui ci aveva bastonato e al posto dei tecnici nostri erano arrivati quelli inglesi: «Prova gli eucalypti» gli avevano detto. «Proviamo» aveva fatto Menelik, e questi eucalypti si erano adattati lì meglio che a casa loro.
Da noi nel 1935 – in Agro Pontino, quando zio Adelchi era partito per l’Africa Orientale – erano arrivati a quattro metri, che non è la fine del mondo ma che è comunque già un alberello, non più solo il cespuglio dell’anno prima. E tutti pieni di foglie odorose. E quando poi lui è tornato a casa due anni dopo, erano già più alti del podere: «Ma tu varda sti casso de calìps» diceva a tutti, ammirato, mio zio Adelchi.
In realtà l’unica che li guardasse ammirata quanto lui era l’Armida – la moglie di zio Pericle – per via delle sue api che andavano pazze per questi eucalypti. Non le aveva mai viste così. Un miele da cui esalava un profumo che era la fine del mondo. Tutti gli ormoni in ebollizione, le api. Se vedevano una rosa la schifavano, oramai. Solo i calìps. E l’Armida s’era dovuta far fare due arnie nuove da zio Iseo - che era il più bravo nei lavori di falegnameria – più una per la moglie di lui: «Ti insegno» le aveva detto, perché andavano d’accordo come due amiche, ancora più che sorelle. Insomma, arrivate qua e trovato questo eucalyptus cor le foglioline allungate e i fiori che sembravano pallini da caccia, le api erano impazzite dalla gioia, fottevano dalla mattina alla sera – «Brutte maiale», faceva l’Armida – e in capo a tre anni tutti gli alveari avevano figliato due o tre volte l’anno. Da una, adesso c’erano quattro arnie di legno con i tettucci ognuna d’un colore diverso, sotto l’argine del t anale Mussolini al confine del nostro podere 517. Lei però vada pure a chiedere in giro, non è solo un fatto di quantità, è che proprio non c’è – a questo mondo – un miele migliore di quello d’eucalyptus.
Oggi gli eucalypti si trovano dappertutto in Italia e perfino foreste intere, o filari e fasce frangivento che non finiscono mai. Ma ogni eucalyptus che lei trova disseminato anche nella landa più sperduta e deserta della Sicilia o della Sardegna, è un segno permanente e tangibile di quella che allora si chiamava «Era Fascista».
[...]
Tornando però all’Africa, se lei permette, a noi avevano dato un podere, anzi due per meglio dire. Anzi tre e pure quattro o cinque, se contiamo i Dolfin, i Lanzidei e i parenti della nonna. E tu non ti volevi sdebitare andando in Africa? Abbia pazienza, qualche Peruzzi ci doveva andare in guerra, e quando è arrivato a casa nostra, il Barany ha trovato le porte aperte. Questo Barany era un tecnico dell’Opera, un perito agrario coi fiocchi. Era nato a Paullo, tra Lodi e Milano, ma era di origini ungheresi. Difatti si chiamava Hindart Barany di cognome: Camillo Hindart Barany. Suo nonno se ne era partito a suo tempo dall’Ungheria per venire in Italia a combattere insieme a Garibaldi. Partecipò alla spedizione dei Mille in Sicilia. Poi è rimasto qua e Camillo – il nipote – è stato anche lui garibaldino in Messico e nelle Argonne, al comando di non so quale nipote di Garibaldi, qualche figlio di Menotti o di Ricciotti, non so. Credo che in Messico abbiano combattuto con Pancho Villa o con Zapata. Fatto prigioniero poi nella grande guerra 1915-18, evase dal campo di concentramento austriaco, tornò a combattere e dopo la guerra passò nell’antiguerriglia contro i libici, poi legionario a Fiume, squadrista e Marcia su Roma. Un vero patriota, e tra una guerra e l’altra faceva l’agronomo. Aveva partecipato alla bonifica di Maccarese, poi a quella di Mussolinia di Sardegna – ora Arborea – e alla fine in Agro Pontino. Insomma, o stava in guerra o faceva bonifiche. Tertium non datur. Ed era pure di religione ebraica. Era ebreo. Ebreo-ungherese. Che i miei zii a vederlo così – e chissà come si immaginavano che dovesse essere invece un ebreo – si dicevano sempre tra di loro: «Ghètu visto ‘l Baranì? Non sembra gnànca un zudèo». In Agro Pontino poi, tra una badilata e l’altra, tra lo squadro d’un terreno e la messa a punto d’una qualche nuova tecnica colturale, il Barany aveva messo su con i coloni alcune attività al dopolavoro – una compagnia di teatro amatoriale che faceva quasi sempre commedie di Goldoni, un coro di canti folkloristici alpini – e soprattutto la locale e neonata compagnia Camicie nere della Milizia, la compagnia «Littoria». Pure i miei zii ne facevano parte e ogni sabato pomeriggio – il sabato fascista – andavano a fare le marce e le esercitazioni al Borgo o anche a Littoria. Lui gli diceva sempre: «Più siete in gamba qui, e più sarete in gamba nei campi. Avanti o camerati, eia eia alalà!». «Alalalà!» gli rispondevano i miei zii, sia perché erano fascistissimi come lui, sia perché gli volevano bene – e lui si sapeva far volere bene – e anche perché, non dico soprattutto ma certo nemmeno per ultimo, era l’agente agrario dell’Opera combattenti.
Comunque appena è scoppiata la guerra d’Abissinia e ha sentito la voce della patria, il Barany non ci ha visto più: «La Patria chiama». Ha buttato all’aria tutti gli strumenti, gli squadri, le livelle, le provette dell’Opera combattenti ed è corso ad arruolarsi per andare di nuovo a combattere insieme a tutta la compagnia «Littoria» sua. Venne a prenderci casa per casa, podere per podere uno per uno: «All’erta camerati, a conquistar l’Impero! Chi viene di voi?». «Comandi, qualcuno vegnerà» rispondemmo tutti quanti. Non è difatti che si dovesse insistere troppo per trovare volontari a Littoria. Anzi, parecchi li rimandarono pure indietro: «Siamo troppi». Quelli – le ripeto – ci avevano dato la terra e mo’ che la patria chiamava, tu manco volevi rispondere: «Volontario!»? Li abbiamo riempiti di volontari fino all’ultimo battaglione «M» della Rsi, fino alla X Mas. Ora lasci stare – le ripeto – che pure agli Abissini li chiamava la patria loro; anzi, eravamo noi che andavamo ad invadergliela. Ma noi credevamo così, punto e basta, è inutile stare ad insistere, il dramma della condizione umana è proprio questo: sei quasi perennemente condannato a vivere nel torto, pensando peraltro d’avere pure ragione. E noi mandammo zio Adelchi: «Toca a lù stavolta» perché era l’unico, dei fratelli grandi, che non fosse ancora sposato e con figli. E «Toca a mì stavolta» aveva detto subito lui stesso peraltro – prima ancora che i fratelli parlassero -perché qui c’era da lavorare dalla mattina alla sera e un po’ d’avventura, pensava lui, e vedere il mondo non gli avrebbe fatto male. E così quando il Barany venne a casa la sera a dire «Chi viene?», zio Pericle non lo fece neanche parlare e gli chiese solo: «Andrebbe bene l’Adelchi?».
«Certo che va bene l’Adelchi» rispose Barany, perché gli stava simpatico. E poi, diciamoci la verità, zio Adelchi era fatto proprio per la divisa. Ai Peruzzi le bestie – come si suole dire – ai Benassi i trattori, agli Adelchi i galloni. A zio Adelchi la divisa era sempre piaciuta. Fin da bambino non aveva fatto che dire alla madre, mia nonna: «Da grande voglio diventare carabiniere». O non so se fosse stata proprio lei, invece, a dirgli da piccolo: «Ah, tu bisogna proprio che fai il carabiniere». Lui era il cocco della nonna, il preferito. Lei se lo ricorderà sicuramente, era alto e moro moro. Nella nostra famiglia o biondi o mori – alternati quasi ogni due anni, maschi e femmine – un biondo ed un moro, un biondo ed un moro: zio Pericle biondo e zio Adelchi moro moro. E anche da piccoli non è che si prendessero molto, lo riempiva di pugni in testa mio zio Pericle, che invece era legatissimo a zio Iseo, quello venuto subito dopo zio Adelchi. La forza d’un leone però ce l’aveva anche zio Adelchi, e le spalle ampie, il sorriso largo sui denti bianchi, il viso perfetto con le ciglia scure, i capelli neri foltissimi col ciuffo ad onda che portava sempre da una parte – una criniera appunto, sempre curata e lucidissima di brillantina Linetti – e lo sguardo allegro e fiero che diceva al mondo: «Mondo, son qua per far contento te». E con questo sguardo -diceva mia zia Bìssola – pare che fosse uscito direttamente, già a suo tempo, dal ventre di sua madre. Come si faceva a non innamorarsene? Ora zio Adelchi lo sapeva benissimo, naturalmente – e lo sapeva benissimo anche mia nonna – che non era lui il primogenito. Il primo maschio da noi – quello in cui immediatamente dopo mio nonno risiedeva la massima potestas -era zio Temistocle, e il fatto che sua moglie non piacesse a mia nonna era secondario. Non le piaceva però se la teneva, era lei – volere o volare – la donna che avrebbe preso il suo posto. Poi appena arrivati qui e avuti due poderi e mio zio Temistocle il suo tutto per lui, mia nonna non ci aveva pensato un attimo a dirgli: «È il tuo e fai tutto per te, per parte tua». Lui aveva pure tentennato: «No, no, mamma. Siamo una famiglia sola, siamo pure tanti, continuiamo a fare tutti insieme una famiglia sola». «No, no, è giusto così» e mia nonna dentro di sé era al settimo cielo, perché con la moglie di Pericle invece andava d’amore e d’accordo, come ci andavano anche tutti i cognati eccetto le femmine. E così zio Temistocle aveva fatto famiglia per conto suo e a quel punto – come è giusto che fosse – subito dopo mio nonno la potestas era passata a zio Pericle, senza neanche bisogno di dirlo. Lo sapevamo già tutti. Lo sapeva quindi pure zio Adelchi di essere solo il terzo maschio, e mai gli è passato in mente di porlo in discussione. Anzi, quando appena divisi con zio Temistocle, zio Pericle aveva detto: «Va bene, mamma, adesso siamo qui, e terra nuova vita nuova. Da oggi in poi tutti i più giovani bisogna farli studiare, debbono diventare qualcuno, perché nessuno possa più imbrogliare i Peruzzi come hanno fatto gli Zorzi Vila», subito zio Adelchi aveva fatto cenno di sì, che lui era d’accordo. Pure il nonno da un canto diceva di sì con la testa. Solo mia nonna provò a dire: «Ma i schèi? Quanto ne costerà? Come faremo?».
«Faremo, faremo!» disse subito zio Adelchi, manco l’idea fosse stata la sua.
«E se n’i gà la testa?»
«Gliela faccio venire io a calci.»
E fu così che mandarono i miei zii più giovani a scuola. Quando stavamo su, sì e no che si faceva la seconda o terza elementare. Invece qui – finite le elementari al Borgo – ci mandarono tutti i giorni a Littoria in bicicletta, creature di dieci o dodici anni come zio Cesio e zia Ondina, sotto l’acqua d’inverno. E quando facevano storie, davvero zio Adelchi ce li mandava a calci: «L’è pel vostro bèn, desgrassià».
«Ma mì ago fredo!»
«Viaaa!» mandava uno strillo acuto allora, perché quando strillava – non so se gliel’ho detto – la voce gli si faceva aguzza.
[...]
Come dice, scusi? che il Barany però era un fascista?
Ho capito. Però è sempre un mio Antenato e quella notte che è caduto c’era pure mio zio Adelchi con lui sull’Amba Aradam. O meglio, non proprio sopra ma sulle falde. Sopra c’erano ancora gli etiopi – e tutto intorno – e se mio zio diceva di non avere mai visto i gas, diceva però anche che quella notte sull’Amba Aradam, nascosto in una fossa col compare Franchini, aveva sentito a un certo punto, a un rapido mutare del vento, un forte e persistente puzzo d’aglio e di cipolla che, lei sa, è l’odore appunto dell’iprite.
[...]
Erano passati tre mesi dall’attentato e mio zio Adelchi e il compare Franchini stavano tranquilli negli acquartieramenti. In un giorno di maggio però li hanno caricati sui camion e in serata – insieme ai colleghi loro – hanno circondato Debra Libanos, che era costituita da due grandi chiese in muratura e un migliaio di tucul in cui abitavano i religiosi. Nei giorni seguenti hanno fatto tutto un mucchio di questi preti, sottopreti, vescovi, abati, diaconi, seminaristi, studenti di teologia, chierichetti, monache, suore, educande e qualche pellegrino, e ne hanno portata una parte sulla riva di un canyon lì vicino – nella piana di Laga Wolde – in fondo al quale scorreva un fiume che era quasi secco. Li hanno fatti mettere in fila sullo strapiombo e con le mitragliatrici li hanno falciati tutti. Poi sono passati a dare i colpi di grazia, una spinta e giù nello strapiombo. Era il 21 maggio 1937 e alle quattro del pomeriggio lì da loro -da noi saranno state le tre – era tutto finito. Mio zio stava in un plotone di guardia messo di fianco alle mitragliatrici e doveva sparare con il moschetto a quelli che eventualmente provassero a scappare.
«Ma questi sono preti, compa’» faceva il povero Franchini.
«Sì, ma i xè rètici! Non l’hai sentito il cappellano? Tasi e spara Franchìn, non star farte sentire che qui ne cópa a nantri.»
Quelli avanzati invece – l’altra parte che era rimasta sotto sorveglianza a Debra Libanos – li abbiamo portati cinque giorni dopo a Engechà, verso Debra Berhàn, dove avevamo già scavato con le ruspe due grandi fosse. Ce li abbiamo messi davanti – erano quasi tutti diaconi questi: ragazzini, giovani seminaristi – e anche loro con le mitragliatrici e via.
«Ma questi so’ preti compa’, so’ chierichetti» continuava a fare piano piano, sconsolato, Franchini.
«Tasi Franchìn, tasi, maladéto!» imprecava mio zio.
L’avessero fatta a noi cattolici una cosa così, staremmo ancora a pregare tutti i giorni in piazza san Pietro. Li avremmo fatti tutti santi e io non la vorrei disilludere, ma guardi però che tra portare la democrazia in giro sulle canne dei fucili e portarci gli imperi, non c’è poi tanta differenza. Pure il Duce diceva di farlo per il bene loro: «Agh portèmo la civiltà».
Ora poi – come lei sa – in quell’impero non trovammo un solo chilo di ferro o di carbone, neanche una materia prima, non parliamo del petrolio. Petrolio ce n’era quanto ne avremmo voluto in Libia, ma non ci riuscì mai di trovarlo. Lo trovarono solo dopo. E anche di terra per farci emigrare i contadini ne trovammo quasi quanta l’oro il ferro il piombo, ossia niente. Le terre fertili erano poche, la maggior parte era pietraia. Dia retta a me: la prossima volta che l’aquila imperiale – con tanto di Imperium tra gli artigli – si rimette a svolazzare sui colli fatali nostri, ci conviene chiamare a raccolta l’Arci-caccia e farle sparare subito come al peggior colombaccio.
[...]
In Africa Orientale non è che fosse andata meglio che in quella Settentrionale. Subito dopo l’offensiva nostra difatti, gli inglesi avevano fatto affluire dall’India e dal Sudafrica rinforzi di uomini e mezzi. Truppe fresche e ben equipaggiate. Noi avevamo trecentomila uomini lì. Loro sessantamila. Ma non c’era paragone. L’aviazione nostra era rimasta indietro non solo come velocità, manovrabilità ed armamento dei velivoli; ma anche proprio come numero, perché molti dei vecchi aeroplani di Balbo – divenuti oramai inutilizzabili per l’usura – non erano stati sostituiti. E così le truppe a terra. Eravamo stati i primi a fare una guerra meccanizzata in Africa, usando autocarri e carri armati; ma pure quelli erano rimasti gli stessi. Anzi, non avevamo nemmeno i ricambi di gomme e camere d’aria. I pezzi d’artiglieria erano quasi tutti superati e il munizionamento risaliva in buona parte al 1918. Molte granate – una volta sparate – poi non esplodevano. Le lanciavi e «Puf», niente, non succedeva niente. Gli inglesi invece arrivarono armati fino ai denti e con tutte le armi e gli armamenti all’ultimo grido. Gli mancavano solo i Ray-Ban. Noi a piedi coi moschetti e loro con un mare d’aerei che li coprivano dal cielo, e in terra carri armati, autoblindo e camionette fuoristrada – le antesignane della Land Rover – con tanto di cannoncino e mitragliatrice. “Gazelle Force” la chiamavano. Nel gennaio del 1941 sferrarono un attacco simultaneo da nord e da sud. Erano sessantamila, le ripeto. Noi trecentomila. Ma trecentomila pellegrini. In Africa Orientale non abbiamo potuto chiamare in soccorso i tedeschi. Non potevano arrivare. Suez era chiuso anche per loro. Se no avremmo allungato l’agonia anche lì. Non arrivò nessun soccorso e neanche più un rifornimento dalla madrepatria. Resistemmo il più possibile e ci battemmo anche con valore. Il duca d’Aosta si asserragliò sull’Amba Alagi e resistette fino al 17 maggio 1941. Quando ci arrendemmo, gli inglesi ci concessero l’onore delle armi.
Il Duce disse: «Ritorneremo! L’impero sta là, è nostro e nessuno ce lo tocca. Mo’ vinciamo la guerra in Europa, gli spezziamo per sempre la schiena e poi andiamo lì e ce lo ripigliamo».
Che le debbo dire? Noi davvero gli credevamo ancora. Certo c’era il dispiacere e soprattutto il pensiero e l’ansia per quelli che erano lontani e di cui non si avevano notizie. Mica c’era internet allora – o i telefonini satellitari – e la posta aerea, lei capisce, se la supremazia inglese era totale non poteva certo passare. A un certo punto anche le comunicazioni radio per la truppa erano saltate. Mesi e mesi senza sapere niente. Solo i bollettini di guerra e i proclami del Duce: «Ritorneremo!». Ma che fine avessero fatto i miei zii, solo Dio lo sapeva, diceva mia nonna.
Il primo, fondamentale, è quello di raccontare tramite la saga di una famiglia uno specifico importante evento (la bonifica delle paludi dell'agropontino) e con questo la storia d'Italia e del fascismo dagli anni venti ai quaranta. A scuola non si studia (esperienza personale) o si studia male e la mia generazione e quella successiva rischia di perdere un pezzo insostituibile di conoscenza che è utile anche come chiave di interpretazione del presente soprattutto nei momenti in cui, come dice Pennacchi, "cambia il vento".
Il secondo è il modo originale, coinvolgente, ironico con cui le vicende sono narrate. Merito anche del linguaggio che alterna un italiano volutamente semplice, da persona che lavora la terra, al dialetto veneto.
Il terzo è quello di aver creato personaggi memorabili, dagli improbabili nomi di battesimo (Pericle, Armida, Temistocle, Adelchi,...), caratterizzati magnificamente e che, anche se immaginari, si intersecano alla perfezione con personaggi storici esistiti e fatti realmente avvenuti.
Come marmo levigato che poco per volta inizia a mostrare crepe sempre più grandi, quella che all'inizio sembra un'agiografia del fascismo si evolve nel corso del libro in una critica che culmina con la descrizione delle nefandezze commesse in Africa. Il tutto rimane in un sottofondo smorzato nei toni a volte comici del libro ed è coerente con il punto di vista dei protagonisti che, come la maggioranza degli italiani, era rimasta affascinata dai vantaggi efficacemente propagandati dal regime totalitario. Interessante la chiave di lettura che Pennachi dà della nascita del fascismo, delle sue adiacenze e diversità dal socialismo, delle cause degli attriti tra le due ideologie e di come una ha prevalso sull'altra e ha attecchito in un Italia scossa dalla prima guerra modiale.
Mussolini è stato grande, ha conquistato tutti. Il capolega non aveva fatto in tempo a dire: «Vi presento il compagno Mussolini», che lui un altro po’ si era mangiato i vetri di tutte le finestre sulla piazza. Non si è messo a sputare sul tricolore come il Rossoni in America, ma poco c’è mancato, creda a me. Lei non ha idea di quello che è stato capace di dire a quei quattro mascalzoni, specie al Giolitti «piemontese falso e cortese», il peggio di tutti secondo lui: «Con tutta la fame che abbiamo qua, e con tutti i poveracci che vengono ogni giorno sfruttati e cavati il sangue dai preti e dai signori, andiamo ad aggredire quei poveri baluba per fare schiavi pure loro? Vergognève!» disse il Mussolini, «Specie il Giolitti e il Bissolati». Come diceva mio nonno, quello era uno che quando doveva dire una cosa la diceva papale papale, non ci stava mica a pensare sopra, non aveva peli sulla lingua.
Una volta – mi pare a Losanna, in Svizzera, quando era scappato anche lui per una condanna – a un prete che sparlava in giro lo fece una pezza da piedi davanti a tutti. Poi da sopra il palco – levatosi l’orologio dal taschino e messolo bene in evidenza sulla balaustra del palchetto – disse proprio: «Ma adesso è ora di farla finita anche con il suo principale, Dio non esiste e ve ne do una prova. Lo sfido. Se esiste, gli do tre minuti di tempo per fulminarmi stecchito su questa pubblica piazza. Se invece non succede niente, vuol dire che non esiste. Tre minuti ho detto, punto e basta», restando in silenzio con l’orologio tirato su per aria, per tre lunghissimi minuti. Ora come lei sa tre minuti, a dirli così, sembrano una cosa da niente; ma si metta in silenzio ad aspettare e veda come sono lunghi. E anche a dire «Io sono ateo; Dio non esiste» non ci vuole niente. Ma lei mi deve credere: quella volta sopra al palco a Losanna era tutto pieno di socialisti atei e mangiapreti, ma appena il Mussolini ha detto «Gli do tre minuti di tempo», la gente piano piano s’è stretta e allontanata; attorno a lui s’è fatto il vuoto.
E lui imperterrito ad aspettare i tre minuti e appena sono passati s’è rimesso l’orologio piano piano nel panciotto riavvolgendo la catenella e ha detto soddisfatto: «Che v’avevo detto io? Sono sano e salvo: Dio non esiste». È scoppiato un applauso che lei non ha idea. Ma anche un sospirone generale di sollievo: «Aaaah».
Comunque finito il comizio – quello nostro del 1911 e della Libia – sceso dal palco, la gente gli si è fatta intorno a salutarlo e coi più stretti sono andati a bere un bicchiere come si fa di solito. Pure mio nonno ha fatto il gesto di avvicinarsi per salutarlo, anche se era un po’ intimidito perché pensava che non si ricordasse. Invece come lo ha visto, il Mussolini ha strillato: «Peruzzi! Am dispiase propi ma stavolta n’an pòi vegnèr a manzàr da valtri, ch’ago d’andar via. Ma nol mancarà ocasiòn, t’al sicuro».
E perché ride adesso? Cosa dice? Lei dice che non può essere che Mussolini parlasse così, perché lui era romagnolo di Predappio, tutto un altro dialetto, un’altra inflessione?
Lei la deve smettere con queste fesserie, io mica sto qui a raccontare barzellette. Cosa vuole che ne sappia io di quale dialetto e con quale inflessione parlasse Mussolini? Quelle sono però le cose che ha detto – la sostanza – e io gliele ridico parola per parola esattamente nello stesso dialetto in cui le hanno dette a me. Io non cambio niente.
[...]
Poi c’è stata Caporetto come lei saprà, coi tedeschi che hanno rotto il fronte e tutti noi a scappare davanti a loro che avanzavano: chi buttava i fucili, chi abbandonava i cannoni e chi sparava addosso ai propri ufficiali che cercavano di trattenerli. Solo alcuni però degli ufficiali. Alcuni altri si suicidarono, per il disonore. Ma la maggior parte sono scappati per primi, gli alti gradi degli stati maggiori e gli ufficiali di truppa; poi alla fine – quando è stata la fine – la colpa era solo dei soldati, e gli ufficiali si sono salvati tutti, più belli e più tronfi di prima e hanno fatto pure carriera come Badoglio, che fu tra i primi responsabili di Caporetto. I soldati che erano scappati, invece, li hanno ripresi e fucilati tutti. O meglio, tutti no. I reparti che interi s’erano dati alla fuga – i plotoni, le compagnie, i battaglioni – i carabinieri li mettevano in fila e poi contavano «Uno, due, tre, quattro, cinque: tocca a te», e quello era fatto: «Al muro!». Agli altri gli era andata bene. Decimazione si chiamava. Pure a zio Temistocle a un certo punto era preso il panico a Caporetto, perché la paura è contagiosa. Più vedi gente intorno a te che ha paura, e più ne viene pure a te, è un fatto di rassicurazione, di determinazione nel convincimento. Prima magari pensavi dubbioso: «Chissà se è il caso di avere qualche preoccupazione». Però non lo dicevi – lo tenevi per te – anche per non fare con gli altri la figura di quello che non ha coraggio. Ma appena vedi che hanno paura gli altri, allora subito ti dici: «Ah, ma qui c’è davvero da avere paura» e ti metti le gambe in spalla e via. Tu appresso agli altri e gli altri appresso a te. E così pure zio Temistocle – a vedere i tedeschi che venivano avanti come demoni, e i nostri invece indietreggiare come lepri e buttare i fucili per poter correre più forte – pure lui a un certo punto ha voltato le spalle ed è scappato. Lui però non ha buttato il fucile, non se l’è sentita. «Non si sa mai» ha pensato. E difatti gli è venuto buono dopo, quando ha trovato un gruppetto che diceva: «Dove andate, vigliacchi» e a quelli senza fucile li fucilavano lì sul posto. Ma a lui il “vigliacco” lo aveva smosso nell’orgoglio, e s’è fermato pure lui a opporre resistenza al nemico «Male che va, i me cópa» – e hanno messo in piedi un tentativo di ripiegamento ordinato. È lì che gli hanno poi dato la medaglia di bronzo, anche se lui diceva che gliel’avevano data giusto per far vedere, perché lui non è che abbia fatto atti di particolare eroismo quella volta. Lui lì s’era fermato e basta. Ce ne voleva molto di più a scattare – come aveva fatto tante volte prima, e pure dopo – dalle trincee all’arma bianca, all’assalto, a scannare tedeschi col pugnale. Lì invece – a Caporetto – fu più la gente nostra che scannò, italiani, disertori, e anche a lui toccò stare nei plotoni d’esecuzione, e ogni volta pensava che era solo per un pelo che non c’era lui, al muro, al posto di quello.
Dopo tre anni che si stava in guerra, l’Italia era ridotta allo stremo. E non solo per la fame, i viveri e tutto quanto. Oramai non c’era quasi più gente da mandare in battaglia. E allora, per tirarsi su da Caporetto, hanno dovuto chiamare alle armi anche i ragazzini, le ultime classi, il 1899, la classe di mio zio Pericle, diciotto anni: «Un putìno» diceva mia nonna, «un tosatèo».
Era un po’ cresciuto rispetto a prima, ma ancora mica tanto. Mingherlino, magrolino, biondino, aveva solo questi occhi che sembravano elettrici, occhi azzurri che non stavano mai fermi; ti guardava di qua e di là, era tutto scatti e nervoso come un’anguilla. Gli è toccato partire anche lui. E a mio nonno gli si è stretto il cuore: «Va’ in malora alla guerra e a mì che l’ho voluta».
Lui invece – zio Pericle – era tutto contento perché chissà quante volte, mentre guidava i buoi in campagna, s’era sognato a occhi aperti le scene di guerra e lui che saltava a sbaragliare il nemico. Dentro di sé, sicuramente, un po’ di paura ce l’aveva, però non la lasciava vedere, faceva il gradasso. È partito contento, allegro – o almeno pareva -coi fratelli e le sorelle ad accompagnarlo fino in fondo allo stradone, fino alla strada grande. Sono andati tutti eccetto zio Adelchi che è rimasto a casa – «Ghe xè da lavorar, qua» – sia i più grandi che i più piccoli, coi più piccoli che strillavano per farsi prendere in braccio o a cavalluccio, sulle spalle, per l’ultima volta. E quando alla fine sulla strada grande è passato uno dei carri che ogni giorno andavano verso Adria e poi a Rovigo, avanti e indietro coi bidoni del latte, zio Pericle ha fatto un segno con la mano e il conducente ha detto: «Salta su».
Allora ha dato un bacio uno per uno a fratelli e sorelle, dal più piccolo al più grande, e poi ha abbracciato la madre, mia nonna, e lei ha detto: «Torna a casa figlio, torna sano e salvo» e glielo ha detto con la voce incrinata, non piangeva, però la voce era incrinata, ne aveva due alla guerra adesso e non sapeva più se le preghiere potessero bastare, e sempre con quel pensiero fisso del prete, che non bisogna mancar loro di rispetto e che prima o poi si paga, certe cose non possono non portare male – «Sto bene io a pregare» – neanche un presentimento ma una certezza, quasi, di sciagure.
Lui invece rideva, la abbracciava e rideva: «Non state a preoccuparvi mamma, vado là, vinco la guerra e torno». Ma forse faceva solo finta di ridere. Poi ha abbracciato il nonno per ultimo, mentre il carrettiere insisteva: «Salta su, che il cavallo mi perde il passo», e non si sono detti una parola padre e figlio, solo stretti forte, evitando anche di guardarsi negli occhi, tutti e due sapendo già cosa ci fosse scritto. E poi, con un balzo, a eassetta e il carro è partito e lui ha ristrillato alla madre: «Non stì a preocuparve mama, l’erba cativa n’al more mai. Mì al torno vinsitor». E infatti è tornato vincitore.
Sono andati lui e quelli come lui – i ragazzi del ‘99 – e hanno vinto la guerra. Sì lo so che non l’hanno vinta solo loro, c’erano anche gli altri, ma allora si diceva così: «L’hanno vinta i ragazzi del ‘99». Ragazzini di diciotto anni schierati sul Piave e poi all’assalto, sotto le bombe, gli shrapnel, i gas. E si sono fatti grandi così.
[...]
Erano venuti quelli della lega contadina – i rossi, i socialisti della camera del lavoro -a dire che ogni mezzadro doveva prendersi la sua quota di braccianti, “imponibile di mano d’opera” lo chiamavano. C’era tanta disoccupazione, tanta fame, e allora quelli avevano detto: «Ogni tot di ettari di terra, ci deve stare un tot di operai a giornata e tutti i mezzadri li debbono assumere». Ora io capisco che detta così può sembrare anche giusta, perché anch’io sono d’accordo con lei che il lavoro – come la ricchezza – andrebbe diviso tra tutti quanti. Ma noi sulla terra nostra non avevamo bisogno di tutti questi operai. Chi li pagava? Va bene che eravamo a mezzadria: il padrone metteva la terra, noi il lavoro e si divideva il raccolto. Ma anche le spese andavano divise in due: le sementi, le scorte e gli eventuali operai esterni, i braccianti. Anche per questi andavano divise le spese. E chi ce li dava a noi questi soldi? Certo, quando proprio servivano un po’ di braccianti perché il lavoro era troppo o c’era fretta, pure noi li avevamo sempre presi, mica eravamo scemi. Se devi fare un raccolto e il tempo è stretto, mica ci stai a pensare sopra, chiami la gente di fuori e via. Ma un conto è che lo decido io – ovvero mia nonna – quand’è che serve davvero, un altro conto è che arrivi tu e dici: «Da oggi in poi devi mettere a lavorare in campagna Tizio e Caio». E se a me non serve? Ti chiamo a lavorare a te – e ti debbo dare pure i soldi, perché lo dice la lega – e intanto i figli miei li tengo a casa a non fare niente? E che me li sono fatti a fare allora tutti questi figli? Dov’è che li mando a lavorare? Che gli do da mangiare a loro, se lo do a te? Ho capito che bisogna dividere, ma bisogna dividere quello che si ha, non quello che non si ha. «Noi ne abbiamo a sufficienza solo per noi» aveva detto mio zio Temistocle a quelli della lega, dopo essersi consultato al volo – con lo sguardo – con la madre e i fratelli.
[...]
Come dice, scusi? perché ci chiamassero cispadani e perché soprattutto il fascio avesse dato le terre prosciugate a noi – facendoci venire dall’Altitalia – e non a loro che erano già qui? A lei pare un’ingiustizia? Lei dice che il motivo forse è che quelli di queste parti non fossero abbastanza fascisti? No, questo no. Erano fascisti come in tutta Italia. C’era il fascio locale fin dall’inizio dappertutto e s’erano fatti la marcia su Roma anche loro come tutti gli altri. Certo, pure loro prima avevano avuto i socialisti e le camere del lavoro. Ma come dappertutto, a un certo punto era cambiato il vento pure qui – oggi va di moda una cosa, domani un’altra – e tutti erano diventati fascisti. Né più né meno degli altri. Lei ha presente come ancora pochi anni fa – in tutto il Norditalia – erano tutti democristiani o comunisti e il giorno dopo tutti della Lega o berlusconiani? Se lei va a vedere uno per uno quelli che cucinano la bistecca, salsiccia e fagioli alle feste della Lega, la maggior parte li hanno già cucinati alle feste dell’Unità. Così va il mondo, che vuole da me? Innanzitutto però a noi dissero che era per ripagare il Triveneto dei danni e dolori subiti nella guerra ‘15-18. Secondopoi, quelle nostre erano le zone più povere d’Italia, i più morti di fame e disoccupati che riempivano le navi degli emigranti per le Americhe. Chiusasi quella emigrazione – là non ci volevano più, esattamente come noi oggi con gli extracomunitari – da qualche parte ci dovevano mandare. Ci hanno mandato qua. Eravamo gli extracomunitari dell’Agro Pontino. E poi però – come le ho già detto – all’Opera servivano mezzadri o coltivatori diretti, che sapessero fare tutti i lavori e che risiedessero stabilmente sul podere. Questi qui invece erano abituati a tornare ogni sera al paese loro. Chi ce li faceva restare di notte – con la paura della malaria – appresso alle bestie nella stalla? La mezzadria in Italia era praticata solo in Toscana, Umbria, Marche e Valpadana. Nel Lazio – negli Stati della chiesa -non c’era mai stata, c’era solo e sempre stato il feudalesimo e il primo in assoluto che avesse introdotto la mezzadria nelle terre sue nel Lazio, a Magliano Sabina, era stato proprio il conte Cencelli. Anche per questo, forse, il Rossoni lo aveva consigliato al Duce per l’Opera combattenti.
[...]
I miei zii oramai erano in contatto col fascio di Ferrara e quello era un periodo caldo. Alla fine di agosto – il 30 di agosto del 1920 per la precisione, anche se i miei zii non lo sapevano ancora, in quel momento, che la cosa li avrebbe potuti in qualche modo interessare – erano cominciate le occupazioni di fabbrica da parte degli operai di Torino, e poi s’erano estese a Milano. Era la Fiom, il sindacato dei metalmeccanici, che aveva messo su dei Consigli di fabbrica tali e quali ai soviet. C’era appena stata la rivoluzione in Russia e loro la volevano fare anche qui. Intanto avevano cominciato con queste occupazioni per prendersi le fabbriche e diventare loro padroni – il proletariato – e mandare i padroni a lavorare. Era pressappoco quello che volevamo anche noi sindacalisti rivoluzionari nella settimana rossa del ‘14 e loro quella volta avevano detto: «Non è possibile. Bisogna fermarsi qua» e così perdemmo. Adesso invece erano loro a dire: «Facciamo la rivoluzione, occupiamo le fabbriche» e tutto questo periodo – i due anni che vanno dal 1919 fino agli inizi del ‘21 – lei sui libri di storia lo trova proprio scritto “biennio rosso”. Scioperi, occupazioni di fabbrica, manifestazioni e violenze ogni giorno. Non s’era mai vista una cosa del genere in Italia e lo stesso senatore Agnelli – dopo che gli avevano occupato la Fiat ma anche l’Ansaldo, la Pirelli, e tutto il fior fiore dell’industria e del capitalismo italiano – s’era oramai rassegnato anche lui e aveva deciso, d’accordo coi più stretti collaboratori: «Va bene va’, non c’è più niente da fare, siamo con l’acqua alla gola. Chiamateli e mettiamoci d’accordo: io gli do la fabbrica in proprietà comune, mia e loro, e da adesso in poi la portiamo avanti insieme, io e loro». Sono stati i collaboratori a dirgli: «Senato’, la scongiuriamo, aspetti ancora qualche giorno».
«Va bene, aspettiamo ancora qualche giorno» perché ogni tanto i collaboratori bisogna pure farli contenti, anche se lui – dopo un mese d’occupazione – s’era messo l’anima in pace ed era oramai pronto a trattare: «Almeno finisce questa storia e ripigliamo a lavorare, meglio che gliela dia io in fin dei conti, prima che me la prendano loro con un calcio nel sedere; un direttore gli servirà sempre». Ma anche questa volta – tale e quale alla settimana rossa del ‘14 -chiacchiere e basta, altro che rivoluzione. Tanto è vero che neanche dopo un mese – alla fine di settembre – in cima alle fabbriche di Milano e di Torino hanno tolto le bandiere rosse con la falce e martello dei Consigli di fabbrica, i nuovi soviet, e hanno fatto tornare buoni buoni gli operai a lavorare sotto gli stessi padroni, agli ordini degli stessi identici capi. E non solo senza avere fatto la rivoluzione o preso il potere, ma alle stesse identiche condizioni di prima. Anzi, i capi erano pure più boriosi e i collaboratori più stretti del senatore Agnelli sono andati poi avanti anni a rinfacciargli: «Ah, se non c’eravamo noi quella volta! Se era per lei avevamo perso tutto». Tanto che alla fine gli ha dovuto dire: «E mo’ basta! Il prossimo che lo dice un’altra volta lo caccio sui due piedi». Ora però anche un bambino sa che se chiami in continuazione la gente alla lotta senza fargli mai ottenere risultati tangibili, quelli alla lunga ti mollano e non ti ascoltano più: «Al lupo, al lupo». Anzi, più li hai fatti lottare senza un costrutto, e più a quelli gli passa la voglia di rilottare un’altra volta: «Ma che sono scemo? Vado a ripigliare le bastonate gratis?». E comunque quel biennio rosso è andato avanti tutto il 1920 – dal 1919 che era iniziato – fino al 1921, che è stato pure peggio perché è arrivato il “riflusso” delle lotte, come lo chiamava Lenin (lei non so se lo sa che il Lenin e Mussolini s’erano conosciuti in Svizzera prima della guerra -esuli squattrinati tutti e due – nel 1903 o ‘4. Si incontravano in giro per Losanna, che era piena di rivoluzionari che ogni volta per la strada si chiedevano l’un l’altro: «Ghètu un franco da prestarne?». Adesso non so se ci fosse anche il Lenin quando Mussolini sfidò Dio – «Vieni qua e fulminami» – con l’orologio in mano. Comunque nel 1917 quello fece la rivoluzione in Russia e prese il potere, e Mussolini leggendolo sul giornale disse: «Va’ il Lenin va’, son contento par lù». Quando invece nel 1922 ha fatto la marcia su Roma ed è andato su lui, il Lenin disse proprio a Stalin: «Va’ il Mussolini, va’! L’avevo sempre detto io, che l’unico rivoluzionario in Italia era lui». Ed era tutto incazzato con la sinistra nostra italiana che se lo era fatto scappare). Ma oltre al riflusso loro c’è stata la reazione nostra, e oramai era lotta a coltello, con sparatorie, incendi, morti e feriti. Rossi di qua e neri di là. E noi stavamo con i neri – anzi, eravamo i neri – e una volta anche i miei zii sono tornati con zio Pericle, steso sul pianale del carro.
[...]
Noi però oramai stavamo col fascio di Ferrara, dipendevamo da lì. E a Ferrara comandava Italo Balbo. Il Rossoni invece stava a Milano a dirigere i sindacati fascisti e con il Balbo non si è mai potuto pigliare. Il Balbo era uno che, dove c’era lui, doveva comandare tutto lui. Anche al Mussolini – fino all’ultimo – gli ha sempre detto: «Tu comandi su tutto e io obbedisco. Ma nel poco che mi dai da comandare a me, ci comando solo io e neanche tu ci metti bocca». E difatti anche col Mussolini – pure dopo che è diventato Duce – non è che ci si sia mai tanto preso. Il Duce alla fine non lo poteva proprio più vedere, perché era l’unico che anche in Gran Consiglio continuava a dargli del tu. A quello gli rodeva. Gli sembrava che non rispettasse il grado e lo ha mandato in Libia: «Va a fare il Governatore là, fora dai piè». Anzi, si dice che – ma i miei zii non ci credevano e neanche io ci credo – fosse stato lui a dare l’ordine alla contraerea di sparare, altro che sbaglio, quella volta che Balbo tornava da un volo sull’Egitto. Era appena scoppiata la Seconda guerra mondiale e dalla San Giorgio – una nave da battaglia che era stata interrata apposta, per proteggere meglio la piazzaforte di Tobruk – vedendo questo apparecchio che arrivava, si sono creduti che era un apparecchio inglese e allora via tutti a sparare Fino a che non lo hanno preso ed è caduto giù. E subito i marinai a tirare i berretti in aria per la contentezza: «O ghémo ciapà, o ghémo ciapà», perché pare che poi la San Giorgio non ne abbia più preso uno solo di apparecchio nemico. Né prima né dopo. Tutti passavano e non gli succedeva niente – l’antitriangolo delle Bermude – e s’era sparsa la voce tra i piloti britannici: «Passiamo sulla San Giorgio che lì non ci prendono neanche se viene giù Cristo». Solo quello hanno preso d’apparecchio in vita loro. E non gli pareva vero. Poi però, quando sono andati a vedere, era il Balbo; avevano buttato giù lui, i lo ghéva copà. E la gente in Italia diceva che non era stato un errore – era stato un tradimento – perché il Duce era geloso e aveva paura che il Balbo gli levasse il posto. Queste sono tutte chiacchiere naturalmente, ciàcole dicevano i miei zii, anche se adesso s’è scoperto che quel giorno in rada c’era pure lo Scirè – un sommergibile famoso per le operazioni speciali supersegrete – e aveva sparato pure lui senza dire niente a nessuno. Era arrivato la sera prima ed è ripartito il giorno stesso, neanche un’oretta dopo che l’aereo del Balbo era stato abbattuto. Poi faccia lei; però rimane il fatto che quello, il Balbo, era un grande organizzatore, una macchina piena d’energia e fu lui che nel 1924 – quando oramai Mussolini stava nel pallone per il caso Matteotti – fu lui che gli diede la scossa e lo resuscitò come Lazzaro. O Frankenstein. Tutti lo attaccavano in parlamento oramai. Era rimasto solo come un cane, aveva poche ore – dicevano tutti quan ti – si doveva dimettere perché il caso Matteotti era trop po grosso ed era lui il mandante. O meglio, lui diceva che non era vero e lo dicevano anche i miei zii: «È stato il Dumini che ha sbagliato tutto». Ora però sarà pure vero che forse ha sbagliato il Dumini e che loro non volessero uccidere, gli volevano solo dare una lezione e basta al Matteotti che il 30 di maggio del 1924, in parlamento, a Mussolini gliene aveva dette di tutti i colori. Lo aveva fatto diventare una bestia, tanto che appena uscito dal parlamento – proprio lì sul portone dell’aula, rosso di brace, tutto infuriato e fumante – Mussolini aveva urlato a Cesarino Rossi, il segretario particolare suo che sapeva vita morte e miracoli e ogni più piccolo impiccio suo: «Che fa il Dumini?». Ed era incazzato nero. Questa è storia. Loro il Dumini a Roma ce lo tenevano apposta – pagato e stipendiato dal Viminale con tutta la squadraccia sua, la “Cèka nera” come la chiamavano – proprio per questo tipo di evenienze. Così quando il Cesarino Rossi è andato dal Dumini a ridirgli: «Ma che cosa ci stai a fare tu? A mangiare e bere a tradimento? Che stai ad aspettare? Che fa il Dumini! ha detto il Duce» quello ha capito al volo e ha chiamato tre o quattro dei suoi. Sono partiti con la macchina. Hanno preso il Matteotti al Lungotevere. Lui non voleva salire. S’è difeso. Quelli hanno cominciato a menare. Lo hanno caricato a forza. Ma lui si difendeva pure in macchina. E quelli hanno rimenato più forte. Erano partiti per dargli solo una lezione – almeno così hanno detto – ma a un certo punto hanno tirato fuori un pugnale e una lima e lo hanno ammazzato a coltellate. S’erano portati appresso i pugnali. Poi lo hanno nascosto e sotterrato in un bosco. È stato ritrovato – il povero Matteotti – solo due mesi dopo, il 16 di agosto, e Mussolini era di nuovo incazzato: «Ma che avete fatto?».
«Ma me lo hai detto tu» gli rispondeva il Cesarino Rossi: «Che fa il Dumini?».
Allora – nel 1924 – il Mussolini dipendeva ancora dal parlamento e il parlamento lo ha messo in croce. Era additato per tutta Italia come un assassino, un presidente del consiglio parlamentare che se un deputato gli ha parlato contro, gli manda i mazzieri e gli assassini sotto casa. Tutta la nazione scandalizzata lo stava lasciando solo. Tutti sull’Aventino. Tutti i giornali a dire: «Il caso Matteotti di qua, il caso Matteotti di là». E anche un
sacco di fascisti se ne stava andando e anche un sacco di gente che s’era messa dalla parte sua ma che adesso – vedendo la mala parata – si rivoltava già da un’altra parte: «Eh no, queste cose non si fanno», come se prima non lo avessero saputo che al potere c’era arrivato così, con le schioppettate, e da che mondo è mondo funziona così, il potere mica è pulito, diceva mia nonna. Se tu sei pulito, al potere non ci vai, fai un altro mestiere, non ti metti a cercare il potere. Guardi anche adesso: ma secondo lei Pecorelli si è suicidato? A quello gli hanno sparato. È vero che la magistratura ha detto che erano tutti innocenti – Andreotti e Vitalone – ma quello mica si è suicidato. Il potere funziona così, e finché stai in sella, tutti dicono che tu non c’entri niente, che ti hanno solo messo in mezzo; anzi, sono tutte calunnie inventate dai tuoi nemici per screditarti. Ma se poco poco fai la finta di scivolare, tutti quelli che prima facevano finta di niente adesso dicono subito: «Eh no, queste cose non si fanno», e sono i primi loro adesso a darti addosso.
E così era per il Mussolini alla fine del 1924. Solo come un cane. Gli ultimi giorni dell’anno girava come un matto per tutte le stanze della presidenza del consiglio. Girava per i corridoi bianco come un lenzuolo e gli uscieri si aspettavano da un momento all’altro di sentire un colpo di pistola dalla sua stanza, quando restava da solo. È stato così – tra Natale e san Silvestro, mentre lui stava in balìa tra la vita e la morte, tra la fuga e la resa – che Italo Balbo s’è presentato all’improvviso alla presidenza del consiglio insieme a un gruppetto di altri ras, messi insieme da lui, e gli ha detto a brutto muso: «Adesso basta, devi reagire. E se non lo fai tu con le buone o le cattive, lo faccio io e me lo prendo io il potere». Lui era ancora titubante, pareva un ragazzino: «Ma l’opposizione…». «L’opposizione una mona!» lo ha strapazzato il Balbo: «Per cosa lo abbiamo preso a fare il potere allora, per ridarglielo indietro alla prima occasione?». E lui si è fatto coraggio. Si è tirato su con le spalle — pure per non far vedere agli altri ras che aveva paura del Balbo – e un paio di giorni dopo, il 3 gennaio del 1925, ha fatto il discorso alla camera dove ha detto: «Adesso basta, mi assumo io la responsabilità del caso Matteotti, ma chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori: sciolgo i partiti, chiudo i giornali e faccio le leggi eccezionali. Da inquò, da oggi, la democrazia è finita in Italia, comandi solo mè. Xè ditatura».
[...]
Comunque il Rossoni ha detto: «Sentite Peruzzi… per arrivare al potere e cambiare qualche cosa, dobbiamo fare i patti anche col diavolo, anche col re. Pure il Papa se serve. Poi dopo, arrivati al potere, ribaltiamo tutto e ci pigliamo le terre, facciamo una seconda ondata. Ma prima dobbiamo arrivare nella stanza dei bottoni».
«La stansa d’i boton?» ha fatto zio Pericle pensando lì per lì a una cosa pressappoco come quando le sorelle si riunivano nella stessa stanza tutte insieme, a riattaccare i bottoni caduti da braghe e camicie. Poi ci ha pensato e ha detto: «Va bèn Rossoni, rivémo int’la stansa d’i boton». Questa stanza dei bottoni non era per la verità una pensata tutta nostra, dei fascisti o del Mussolini. Era di un amico suo – Pietro Nenni, romagnolo come lui – che si conoscevano da giovani quando erano rossi. Anzi, il Mussolini era rosso, socialista e rivoluzionario. Il Nenni invece – quando si sono conosciuti e sono andati la prima volta in galera assieme – era ancora repubblicano. Poi erano stati interventisti assieme ed è dopo la guerra, coi fasci di combattimento, che si sono divisi. Pietro Nenni nel ‘21 diventò socialista e poi è stato anche segretario ed è stato lui che nel 1963 – sessantanni dopo che lo aveva detto Giolitti – è riuscito a portare i socialisti al governo con la Dc, e ancora andava dicendo: «Adesso sì che entriamo nella stanza dei bottoni». «Ma cos’èia, Pierìn, questa stansa d’i boton?» lo prendeva in giro il Mussolini quando ancora stavano in prigione assieme: «A me mi servirebbe proprio un bottone nuovo» faceva mostrando la camicia sporca e sbrindellata. Per il Nenni il potere era la stanza dei bottoni, una camera dove tu entravi – al palazzo del governo o dal re – e c’era un tavolo grande con tutti i bottoni e tu ne schiacciavi uno e partivano automaticamente gli ordini. C’era il bottone delle banche, quello dei negozi, l’esercito, le guardie, la marina, le fabbriche, le centrali elettriche. Per ogni cosa c’era un bottone che diceva sì o no, bastava schiacciarlo e il treno del Paese andava di qua o veniva di là. «Tutto sta ad entrarci, nella stanza dei bottoni» diceva il Nenni, «poi li schiacci e li manovri e si fa quello che dici tu.» Lui c’è entrato nel 1963. Mussolini invece lo ha anticipato e ci è entrato nel 1922. Poi quello che ci abbiano trovato – dentro quella stanza dei bottoni – lo sanno solo loro. Comunque i miei zii hanno creduto al Rossoni – si sono fatti convinti – perché era convinto per primo lui che fosse quella la strada più giusta per ottenere il riscatto e la giustizia sociale che sognavamo da sempre: «Sapessi tu, a me, come mi sta sullo stomaco quel Balbo, con i suoi agrari e quella sua barbetta da cavrìn». E così finalmente nel 1922 – con la marcia su Roma – siamo entrati nella stanza dei bottoni. «Maestà» gli ha detto il Mussolini al re: «Vi porto l’Italia di Vittorio Veneto» che voleva dire che erano tutti i combattenti – il proletariato contadino che aveva fatto e vinto la guerra – e stavano tutti dietro di lui. A Vittorio Veneto era stata vinta l’ultima battaglia prima dell’armistizio con gli austriaci il 4 novembre 1918. “I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Firmato Diaz” c’era scritto sul bollettino della vittoria che stava oramai attaccato dappertutto, e lei non ha idea di quanta gente in quegli anni, poi, quando gli nasceva un figlio correva subito all’anagrafe: «Firmato! Questo qua lo ciamémo Firmato come il Diaz». Era pieno di Firmati in giro. I miei zii invece – quando magari all’osteria avevano appena detto chissà cosa d’importante – ogni tanto concludevano anche loro: «Firmato Peruzzi!», assestando un bel pugno sul tavolo. Ma anche quando calavano l’asso. Specie mio nonno: «Firmato Peruzzi!».
[...]
E invece questo canchero – a mezzanotte passata, con tutto quel che c’era da fare l’indomani – le si era infilato dietro. «Ma mì lo cópo» e già aveva preso con la mano il coltello grosso del pane. Zio Pericle di là dal tavolo – lei stava di qua, davanti alla tenda che copriva l’ingresso dello sgabuzzino – le ha ridetto piano, perché nessuno sentisse dalle altre stanze: «Agò da parlarte».
«Va’ via! N’agò gnènte da dirte!» ha sibilato piano piano pure lei.
«Ma agò da dirtelo mì» ha insistito zio Pericle quasi pregando, e intanto superava il tavolo e le si avvicinava.
«Va’ via!», ha detto più forte lei minacciandolo con il coltello.
Lui le ha messo una mano sulla bocca – per tappargliela – e con l’altra l’ha stretta forte per un braccio tirandola a sé: «Agò copà un cristiàn, un prete! maladéto mì», e appena finito di dire «maladéto mì» è scoppiato a piangere. E s’è nascosto il viso tra le mani.
In quel mentre – attratto da quell’abbozzo d’urlo della ragazza – s’è affacciato alla porta della cucina un parente del morto, un cugino, che appena ha visto di spalle mio zio singhiozzare ha pensato: «Ma guarda tu quanto bene che gli voleva il Pericle a mio cugino. Chi lo avrebbe mai detto?». Lei subito gli ha fatto segno tranquilla con la mano: «Vai, vai, ci penso io» e quello se ne è andato.
Neanche hanno chiuso la porta. Lei gli ha solo toccato le mani per scostargliele dal viso, per farlo smettere di piangere. Ma appena c’è stato il contatto c’è stata la scossa. Non ha capito più niente nessuno dei due. Mio zio ha rivisto per un attimo il prete e subito ha risentito il «Toc» sordo del cranio che si rompeva sotto il suo bastone e i rantoli e il cattivo odore che subitaneo s’era emanato dallo sfintere non più sotto controllo. L’Armida anche lei ha risentito gli odori del morto suo e il capo che – rivestendolo – senza più vita ondeggiava di qui e di là ad ogni movimento ed il calore che man mano se ne andava, e si faceva gelido, quell’uomo che ancora a pranzo era nel pieno delle forze e la pigliava in giro. E mentre dal corridoio giungeva sommesso il coro delle litanie
Santa Maria. Ora pro nobis.
Santa Dei Genetrix. Ora pro nobis.
Santa Virgo Virginum. Ora pro nobis.
loro si sono buttati oltre la tenda dello sgabuzzino tenendosi strette le braccia. Lei con la mano, da dietro, s’è solo sincerata che la tenda – un cotone sdrucito e rammendato più volte anche da lei stessa – non si fosse per caso impigliata nella madia, senza richiudersi a dovere. E si sono presi con furia, in piedi, appoggiati alla parete di fianco allo scaffale delle bottiglie di pomodoro.
Mater Divinae Gratiae. Ora pro nobis.
Mater Purissima. Ora pro nobis.
Mater Castissima. Ora pro nobis.
continuava il coro delle litanie, con le voci flebili in falsetto delle donne e i toni bassi e forti delle voci maschili
Turris Eburnea. Ora pro nobis.
Ianua Coeli. Ora pro nobis.
mentre zio Pericle le diceva: «Spèteme!» pensando a tutti gli anni di carcere. «Aspettami, Armida, non posso più star sènsa tì.»
E lei ansimando «At spèto, at spèto», rispondeva a ogni colpo andandogli ogni volta più forte incontro: «At spèto par sempre, maladéta mì».
E quando hanno finito – «Amen» diceva intanto il coro -mio zio s’è sentito svuotarsi l’anima, entrare tutta dentro di lei e poi tornare nuova e mondata in lui. E allora ha pensato: «Oggi ho generato dentro di te tutti i miei figli e le mie generazioni». Ma non lo ha detto, perché aveva paura di quel che aveva pensato.
Pure lei però – pure l’Armida – quando lui s’era svuotato, aveva sentito entrare in sé il fiume sacro delle sue generazioni: «Oggi ho concepito dentro di me come le mie api tutti i tuoi figli, che conserverò gelosamente e metterò uno per uno, come le mie api, quando sarà l’ora al mondo».
Poi zio Pericle ha detto: «Spèteme al ponte», ha salutato i vivi e il morto, è uscito ed è andato lì e da allora in poi - per tutta la vita - ogni tanto la sera lei, girata dall’altra parte per dormire dopo avere fatto l’amore, gli ha chiesto dubbiosa nel buio: «Ma se ti dicevo di no quella volta, tu che facevi?». E lui immancabilmente duro: «At còpavo anca tì». Lei gli risaltava addosso, e rifacevano l’amore.
[...]
Erano le zanzare il maggiore pericolo e questo all’Opera – ma anche le maestre a scuola – non facevano che ripeterlo: era lei che pungendoti trasmetteva la malaria. Come dice, scusi? No, no, non si trattava delle zanzare normali che si vedono in giro ancora adesso. Era la zanzara anofele ed era un po’ più grossa, ma non era lei che faceva nascere dentro di sé il bacillo della malaria. Lei quando nasceva era sana. Era solo portatrice e il bacillo lo pigliava andando a succhiare il sangue ai cristiani già ammalati. Quando poi riandava a mordere i sani, l’attaccava a loro. Nelle Paludi Pontine era pieno di gente ammalata. Pure da noi in Valpadana c’era un po’ di malaria, ma non come qui, qui era un’ira di Dio e c’erano tutti i tipi della malattia, non solo quella più endemica, normale, che t’ammazzava piano piano con grandi febbroni periodici e con l’avvelenamento del fegato, l’epatite. Il fegato man mano s’ingrossava e vedevi tutta questa gente qua – e anche i pastori ciociari e abruzzesi e i butteri cavallari di Cisterna – con la pancia grossa grossa. Gonfia. “Panzarotti” li chiamavano, e poco a poco morivano. Ci si curava con il chinino. Passavano i cursori della Croce Rossa a cavallo a distribuirlo in pasticchette, che pigliavamo pure come misura preventiva. In ogni borgo c’erano le dispense, dove appunto «dispensavano» il chinino e dove vendevano anche i sali e tabacchi, perché allora il chinino, il sale e il tabacco erano tutti e tre privative dello Stato. Poi i primi commercianti ci hanno messo anche i generi alimentari, la pasta, l’olio di semi e poi la mescita del vino, l’osteria, il gioco delle bocce e così ancora adesso – che sono cinquant’anni che non s’è più visto un malarico o una pastiglia di chinino – da noi le botteghe d’alimentari continuano a chiamarsi “dispense”. Erano veri e propri general store come i saloon della conquista del West. Lei ci poteva trovare pure le vanghe e i chiodi, se le servivano.
C’erano però anche le forme più pericolose di malaria -la perniciosa o la terzana – che erano capaci d’ammazzarti nel giro di quarantotto ore, con febbri improvvise di oltre quarantadue gradi.
Non c’era il Ddt allora, non c’era niente. Dovevi solo corrergli appresso con la paletta alle zanzare. O meglio: c’erano i pipistrelli – grandi torrette di legno piene di buchi rotondi, messe un po’ qua e un po’ là per tutta la palude in via di bonificazione – in cui i pipistrelli facevano il nido. Ce li avevano portati da tutt’Italia perché il pipistrello è ghiotto di zanzare e le prende al volo meglio di un caccia intercettore. Un F-16. Alle donne facevano un po’ schifo – non è tanto bello il pipistrello, diciamo la verità, e se ti si attacca ai capelli non si stacca più – ma appena hanno cominciato a impiantarsi da soli i nuovi nidi sotto le cantinelle dei cornicioni dei poderi o sulle capriate d’ogni stalla, la gente gli ha fatto gli altarini, gli ha steso i tappeti all’ingresso e li trattava meglio dei bambini in fasce. Le donne mancava poco gli portassero il latte coi biscotti e se solo ti vedevano con la mazzafionda in mano davanti alla stalla – il pomeriggio, quando loro dormono attaccati in fila a testa in giù nell’angolo più buio della capriata – ti schiacciavano di botte più che a una zanzara. È un animale sacro in Agro Pontino e guai ancora adesso a fargli torto.
Però non era Dio, il pipistrello. Da solo non ce la poteva fare in questo universo di zanzare anofeli. L’unico modo per batterle era sterminare dentro l’acquitrino i figli prima che nascessero. Era quella la cerniera del fatale trinomio «anofele-acquitrino-uomo malarico», perché l’anofele – quando fa le uova – le deposita sul filo umido e caldo dell’acqua stagnante, tra dentro e fuori. Ma deve essere acqua ferma, non corrente, se no le uova se le porta via e arrivederci e grazie. Lì l’ovetto si fa tutto il suo percorso di larva e quando è ora rompe il guscio, sale a galla, si dà un scrollatina alle alucce, comincia a svolazzare e il primo cristiano che incontra – malarico o non malarico – si mette a mozzicare a rotta di collo, succhiando e alfin mischiando i sangui.
Per questo bisognava fare la bonifica e asciugare ogni pozza, ogni stagno, ogni padule e scavare canali. Solo acqua corrente doveva esserci, neanche più un bicchiere lasciato all’aperto con una goccia d’acqua ferma. Era peccato mortale – quando siamo arrivati – dimenticarsi per caso un secchio o una bacinella la sera con un po’ d’acqua all’aperto. Ti rimpacchettavano – l’Opera controllava tutto, i fattori facevano avanti e indietro a ogni ora del giorno e della notte, il nostro pretendeva che spazzassimo pure il fondo delle scoline in fianco alla strada, non gli bastava che ne falciassimo l’erba – ti rimpacchettavano e spedivano indietro con tutta la famiglia. Altroché l’ecocidio di cui parlano alcuni, per i quali la palude sarebbe stata un ecosistema che avremmo dovuto ad ogni costo proteggere. E sì, no? Mo’ proteggevamo le zanzare e la malaria?
Come dice, scusi? che così però non vengono più neanche le poiane e gli altri uccelli migratori? Ma che vada in malora anche lei e le poiane. Adesso una poiana ha più diritto a vivere di me? Io vorrei vedere lei al posto nostro, se ci stava lei nelle Paludi Pontine con la malaria. Perché non se le alleva dentro casa sua le zanzare?
Comunque la bonifica non è che si sia fatta dalla sera alla mattina. Ci sono voluti dieci anni per prosciugare e sistemare tutto, da Cisterna a Terracina e dai monti al mare. Bonificavamo un pezzo alla volta e neanche tanto piano piano, ma proprio di corsa. E mentre già c’erano i coloni dentro i poderi nelle aree bonificate, contemporaneamente a valle c’era ancora la palude melmosa e tu correvi il rischio che gli operai – che stavano appunto a scavare i nuovi canali -ti morissero di malaria per le zanzare ancora vive e vegete nel
padule superstite. Nemmeno si sa con precisione quanti siano stati i morti per malaria durante i lavori e tanto meno quanti – presa la malaria qui – se ne siano poi tornati a morire a casa loro in Toscana da dove erano partiti, o anche dalla Calabria, Ciociaria, Sicilia, Bergamasca e tutta Italia.
Più di centocinquantamila furono gli operai impiegati da Opera e Consorzi, e non meno del dieci per cento – quindici o ventimila – debbono essere morti per malaria. Si davano il cambio, facevano un periodo di lavoro e poi subito scappavano con la poca paga a casa loro. E poi Dio vede e provvede. Quelli che invece – «Zac!» – li pigliava all’improvviso la terzana e restavano la mattina in baracca stesi sopra il letto a saltare con la febbre a quaranta, quelli li caricavano su una lettiga e via di corsa a morire a Velletri, in ospedale, perché non risultassero morti di malaria in palude. “Meningite” o “infarto”, scrivevano poi sui certificati di morte, e “Velletri”, non “in palude”, perché il fascio «la malaria l’aveva debellata». Ma che debelli, se poi invece la gente ci muore?
Quelli morivano a Velletri mentre a noi – sugli acquitrini – il fascio faceva spandere manti di carburo misto a sabbia e polvere di strada. Il manto polveroso restava per un po’ a galla e l’anofele – quando cercava di deporre le uova sull’acquitrino – non riusciva a penetrarlo e rimaneva fregata, le uova restavano a seccarsi nella polvere e addio figli. Ma non era con la polvere di strada che potevi debellare la malaria. Era poca roba. Funzionava un giorno o due. In America ci buttavano il petrolio. E quello sì che funzionava. Ma loro il petrolio ce lo avevano. Noi no, noi neanche per accenderci i lumi, si figuri per buttarlo sugli stagni. E la lotta contro le zanzare e la malaria l’abbiamo fatta con la polvere di strada, i pipistrellai, un po’ di «flit» – una specie di insetticida che spruzzavamo con la pompa a mano e un barattoletto attaccato in fondo; ma era più un ricostituente, una Ferrochina Bisleri, per le zanzare che ne andavano ghiotte e ci si ingrassavano come maiali – e soprattutto le carte moschicide che tutte nere pendevano dai soffitti. Oltre naturalmente alle
palette di fil di ferro e alle ciabatte per schiacciare al muro le zanzare, quando le trovavi.
Questa è stata in Agro Pontino la lotta antimalarica fino a tutti gli anni Quaranta e i primi Cinquanta – quando continuavamo ancora ogni tanto a prendere la malaria – finché non è arrivata la Seconda guerra mondiale con gli americani. Allora sì che è davvero finita la malaria, perché se al resto d’Italia hanno portato come si suole dire libertà e democrazia, a noi – che di libertà non ne avevamo mai vista e masticata tanta neanche prima del fascismo, anzi pure peggio – a noi gli americani hanno portato soprattutto il Ddt. Loro lo avevano appena inventato e non lo avevano ancora sperimentato su larga scala. Così quando sono arrivati qui hanno detto: «Provémolo qua!». Hanno riempito un paio di Dakota – certi apparecchioni loro – con tutti questi bidoni di Ddt e avanti e indietro per l’Agro Pontino finché non lo hanno allagato tutto quanto di Ddt. L’esperimento è riuscito – «Orca, se l’è riusìto!» deve avere detto a Truman il generale suo – e non s’è più vista una zanzara anofele in tutto il Lazio e neanche s’è più visto un ammalato di malaria, nemmeno a pagarlo oro. A Velletri hanno dovuto chiudere il reparto. Così gli americani – verificato che a noi cristiani non avesse fatto niente, perché il Ddt sarà anche non-biodegradabile ma sull’uomo non ha alcun effetto negativo; forse, chissà, ce l’ha positivo – gli americani ci si sono tranquillamente andati a disinfestare tutte le paludi loro: «Testato in Agro Pontino» hanno detto. Adesso il Ddt è vietato in tutto il mondo. Perché non è biodegradabile. Resta nel ciclo alimentare e non si dissolve più. Lo hanno trovato perfino nel tessuto adiposo delle foche al Polo Nord. Allora hanno detto: «Basta col Ddt, non si può più fare». Ma a noi ci ha salvati dalla malaria e se non era per il Ddt, noi non ci vivevamo in cinquecentomila su questo territorio.
[...]
Come dice, scusi? perché ci chiamassero cispadani e perché soprattutto il fascio avesse dato le terre prosciugate a noi – facendoci venire dall’Altitalia – e non a loro che erano già qui? A lei pare un’ingiustizia? Lei dice che il motivo forse è che quelli di queste parti non fossero abbastanza fascisti?
No, questo no. Erano fascisti come in tutta Italia. C’era il fascio locale fin dall’inizio dappertutto e s’erano fatti la marcia su Roma anche loro come tutti gli altri. Certo, pure loro prima avevano avuto i socialisti e le camere del lavoro. Ma come dappertutto, a un certo punto era cambiato il vento pure qui – oggi va di moda una cosa, domani un’altra – e tutti erano diventati fascisti. Né più né meno degli altri. Lei ha presente come ancora pochi anni fa – in tutto il Norditalia – erano tutti democristiani o comunisti e il giorno dopo tutti della Lega o berlusconiani? Se lei va a vedere uno per uno quelli che cucinano la bistecca, salsiccia e fagioli alle feste della Lega, la maggior parte li hanno già cucinati alle feste dell’Unità. Così va il mondo, che vuole da me?
Innanzitutto però a noi dissero che era per ripagare il Triveneto dei danni e dolori subiti nella guerra ‘15-18. Secondopoi, quelle nostre erano le zone più povere d’Italia, i più morti di fame e disoccupati che riempivano le navi degli emigranti per le Americhe. Chiusasi quella emigrazione – là non ci volevano più, esattamente come noi oggi con gli extracomunitari – da qualche parte ci dovevano mandare. Ci hanno mandato qua. Eravamo gli extracomunitari dell’Agro Pontino. E poi però – come le ho già detto – all’Opera servivano mezzadri o coltivatori diretti, che sapessero fare tutti i lavori e che risiedessero stabilmente sul podere. Questi qui invece erano abituati a tornare ogni sera al paese loro. Chi ce li faceva restare di notte – con la paura della malaria – appresso alle bestie nella stalla? La mezzadria in Italia era praticata solo in Toscana, Umbria, Marche e Valpadana. Nel Lazio – negli Stati della chiesa -non c’era mai stata, c’era solo e sempre stato il feudalesimo e il primo in assoluto che avesse introdotto la mezzadria nelle terre sue nel Lazio, a Magliano Sabina, era stato proprio il conte Cencelli. Anche per questo, forse, il Rossoni lo aveva consigliato al Duce per l’Opera combattenti. Ora però è anche evidente – come dice giustamente lei -che qui prima di noi non è che non ci fosse proprio mai stato nessuno. Le Paludi Pontine erano un inferno – un deserto paludoso-malarico – però ci stava pure qualcuno qua sopra, prima di noi. E questa è la verità. C’erano innanzitutto i cisternesi – i butteri – che a cavallo proprio come i cowboy andavano appresso al bestiame del principe Caetani o delle altre famiglie nobili romane, i Borghese, i Colonna, gli Annibaldi. Era tutto loro qua, tutto dei nobili e soprattutto dei Caetani. C’era però anche gente dei monti Lepini in palude. Questi in realtà – per la maggior parte – il mangiare se lo procuravano lassù in montagna. Quelli di Cori il grano lo piantavano a Tirinzania e fin sul monte Lupone. A Sezze idem: il frumento per tutto l’anno se lo facevano in montagna, ai Casali e nelle Valli di Suso, che vuol dire proprio «valli di sopra», sopra al paese. Non di sotto. Di sotto, in palude, ci venivano solo i morti di fame, i ricchi no – e neanche quelli non ricchi ma non proprio proprio disperati – a contendersi appunto fame e morte con la palude e la malaria. Però qualcuno ci veniva; a caccia di ranocchie, alla pesca di frodo nelle piscine, a provare a coltivarsi un campicello nascosto da qualche parte. E poi a raccogliere il legnatico e allevarsi qualche porco. I bassianesi – quelli di Bassiano – vantavano un diritto di proprietà secolare collettivo, chiamato università agraria, su parecchie terre della duna quaternaria, nella zona dove adesso c’è Borgo San Donato. Qui diverse famiglie -anche qualche centinaio di persone – risiedevano nei mesi freschi dentro le lestre, che erano gruppi di capanne pressappoco come i casoni nostri del Veneto, fatte di pali, rami, legni, canne ed erbe palustri. E qua i bassianesi ci piantavano il granturco. Ma soprattutto il guadagno loro – sempre se si può dire guadagno, perché non è che fosse proprio un pozzo di petrolio – le popolazioni dei monti Lepini lo facevano coi pecorai che ogni anno calavano dai monti della Ciociaria e dell’Abruzzo. Era la transumanza verticale. I pastori d’estate tenevano le greggi a pascolare in montagna, in altura, e a metà settembre le guidavano a valle: «Settembre, andiamo. È tempo di migrare./Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori / lascian gli stazzi e vanno verso il mare». Alla fine dell’inverno poi – quando in palude ricominciava a fiorire la zanzara anofele e sui monti, invece, iniziava il disgelo, le nevi si scioglievano e rifiorivano i nuovi e freschi pascoli – pecore e pastori ritornavano su: «Ci rivediamo a settembre». C’è ancora oggi – ad attraversare la piana dell’Agro Pontino dai monti fino alla duna quaternaria – una strada che si chiama appunto “strada dei Bassianesi” ed è quella che percorrevano i pastori nella loro transumanza dalla Ciociaria e dall’Appennino a qui e su cui si metteva, armata, la guardia dei Bassianesi a fargli pagare uno per uno ingresso, passaggio e pascolo di pecore e cristiani.
[...]
Quello che più colpì mio zio Adelchi di Addis Abeba quando vi entrò per la prima volta alla testa delle truppe vittoriose subito dietro al maresciallo Badoglio, furono gli eucalypti. «Varda i calìps» disse al suo amico e compare Franchini di Cisterna che marciava al fianco suo – a passo romano e moschetto spall’arm – nell’ultima fila in fondo del plotone d’onore della compagnia Camicie nere “Littoria”, subito dietro alla bandiera di combattimento: «Varda i calìps come ch’i vièn!». Era il 5 maggio 1936 e loro stavano nell’ultima fila perché erano i più alti. «Zitto e marcia, compa’» gli rispondeva però Franchini, «che qua ci puniscono un’altra volta.»
«Ma guarda i calìps come sono grandi, Franchìn! Varda che bestie ch’i vièn.» Bestie appunto da quaranta metri d’altezza. Con dei tronchi che non ce la facevano due uomini grandi ad abbracciarli, e mio zio e il compare Franchini ci si provarono pure. Era tutto un bosco d’eucalypti Addis Abeba, una macchia scura in cui si nascondevano tra i tronchi le abitazioni e da cui emergevano in altezza – fra i rami e le fronde – solo i tetti e le coperture in lamiera dei palazzi più grandi e degli edifici pubblici.
Mai visti prima, ripeto, eucalypti così, perché da noi -appena arrivati – non erano che piantine d’un metro, messe a dimora il giorno prima. Anche i miei zii erano andati a piantarli per conto dell’Opera nei mesi invernali – pagati a giornata per integrare il reddito – lungo tutte le strade, fossi e canali. I primi furono proprio quelli in cima all’argine del Canale Mussolini, piante piccoline appunto, che facevano anche pena a vedersi, fragili e striminzite, con questi filini di foglie allungate come spine di pesce: «Ma sono foglie queste? Sono alberi?». Poi arrivi ad Addis Abeba e trovi queste bestie. «Orca!» aveva detto mio zio Adelchi.
Lì ce le aveva fatte mettere nel 1896 l’imperatore Menelik II Negus d’Etiopia – subito dopo averci sconfitto ad Adua - perché i ginepri che c’erano prima s’erano seccati. «Qua non ci cresce più niente» pare gli avessero detto i tecnici nostri qualche anno prima, quando ancora andavamo d’amore e d’accordo. Poi invece avevamo cambiato idea rispetto all’amore e all’accordo, lo volevamo tutto noi l’impero suo. Allora lui ci aveva bastonato e al posto dei tecnici nostri erano arrivati quelli inglesi: «Prova gli eucalypti» gli avevano detto. «Proviamo» aveva fatto Menelik, e questi eucalypti si erano adattati lì meglio che a casa loro.
Da noi nel 1935 – in Agro Pontino, quando zio Adelchi era partito per l’Africa Orientale – erano arrivati a quattro metri, che non è la fine del mondo ma che è comunque già un alberello, non più solo il cespuglio dell’anno prima. E tutti pieni di foglie odorose. E quando poi lui è tornato a casa due anni dopo, erano già più alti del podere: «Ma tu varda sti casso de calìps» diceva a tutti, ammirato, mio zio Adelchi.
In realtà l’unica che li guardasse ammirata quanto lui era l’Armida – la moglie di zio Pericle – per via delle sue api che andavano pazze per questi eucalypti. Non le aveva mai viste così. Un miele da cui esalava un profumo che era la fine del mondo. Tutti gli ormoni in ebollizione, le api. Se vedevano una rosa la schifavano, oramai. Solo i calìps. E l’Armida s’era dovuta far fare due arnie nuove da zio Iseo - che era il più bravo nei lavori di falegnameria – più una per la moglie di lui: «Ti insegno» le aveva detto, perché andavano d’accordo come due amiche, ancora più che sorelle. Insomma, arrivate qua e trovato questo eucalyptus cor le foglioline allungate e i fiori che sembravano pallini da caccia, le api erano impazzite dalla gioia, fottevano dalla mattina alla sera – «Brutte maiale», faceva l’Armida – e in capo a tre anni tutti gli alveari avevano figliato due o tre volte l’anno. Da una, adesso c’erano quattro arnie di legno con i tettucci ognuna d’un colore diverso, sotto l’argine del t anale Mussolini al confine del nostro podere 517. Lei però vada pure a chiedere in giro, non è solo un fatto di quantità, è che proprio non c’è – a questo mondo – un miele migliore di quello d’eucalyptus.
Oggi gli eucalypti si trovano dappertutto in Italia e perfino foreste intere, o filari e fasce frangivento che non finiscono mai. Ma ogni eucalyptus che lei trova disseminato anche nella landa più sperduta e deserta della Sicilia o della Sardegna, è un segno permanente e tangibile di quella che allora si chiamava «Era Fascista».
[...]
Tornando però all’Africa, se lei permette, a noi avevano dato un podere, anzi due per meglio dire. Anzi tre e pure quattro o cinque, se contiamo i Dolfin, i Lanzidei e i parenti della nonna. E tu non ti volevi sdebitare andando in Africa? Abbia pazienza, qualche Peruzzi ci doveva andare in guerra, e quando è arrivato a casa nostra, il Barany ha trovato le porte aperte. Questo Barany era un tecnico dell’Opera, un perito agrario coi fiocchi. Era nato a Paullo, tra Lodi e Milano, ma era di origini ungheresi. Difatti si chiamava Hindart Barany di cognome: Camillo Hindart Barany. Suo nonno se ne era partito a suo tempo dall’Ungheria per venire in Italia a combattere insieme a Garibaldi. Partecipò alla spedizione dei Mille in Sicilia. Poi è rimasto qua e Camillo – il nipote – è stato anche lui garibaldino in Messico e nelle Argonne, al comando di non so quale nipote di Garibaldi, qualche figlio di Menotti o di Ricciotti, non so. Credo che in Messico abbiano combattuto con Pancho Villa o con Zapata. Fatto prigioniero poi nella grande guerra 1915-18, evase dal campo di concentramento austriaco, tornò a combattere e dopo la guerra passò nell’antiguerriglia contro i libici, poi legionario a Fiume, squadrista e Marcia su Roma. Un vero patriota, e tra una guerra e l’altra faceva l’agronomo. Aveva partecipato alla bonifica di Maccarese, poi a quella di Mussolinia di Sardegna – ora Arborea – e alla fine in Agro Pontino. Insomma, o stava in guerra o faceva bonifiche. Tertium non datur. Ed era pure di religione ebraica. Era ebreo. Ebreo-ungherese. Che i miei zii a vederlo così – e chissà come si immaginavano che dovesse essere invece un ebreo – si dicevano sempre tra di loro: «Ghètu visto ‘l Baranì? Non sembra gnànca un zudèo». In Agro Pontino poi, tra una badilata e l’altra, tra lo squadro d’un terreno e la messa a punto d’una qualche nuova tecnica colturale, il Barany aveva messo su con i coloni alcune attività al dopolavoro – una compagnia di teatro amatoriale che faceva quasi sempre commedie di Goldoni, un coro di canti folkloristici alpini – e soprattutto la locale e neonata compagnia Camicie nere della Milizia, la compagnia «Littoria». Pure i miei zii ne facevano parte e ogni sabato pomeriggio – il sabato fascista – andavano a fare le marce e le esercitazioni al Borgo o anche a Littoria. Lui gli diceva sempre: «Più siete in gamba qui, e più sarete in gamba nei campi. Avanti o camerati, eia eia alalà!». «Alalalà!» gli rispondevano i miei zii, sia perché erano fascistissimi come lui, sia perché gli volevano bene – e lui si sapeva far volere bene – e anche perché, non dico soprattutto ma certo nemmeno per ultimo, era l’agente agrario dell’Opera combattenti.
Comunque appena è scoppiata la guerra d’Abissinia e ha sentito la voce della patria, il Barany non ci ha visto più: «La Patria chiama». Ha buttato all’aria tutti gli strumenti, gli squadri, le livelle, le provette dell’Opera combattenti ed è corso ad arruolarsi per andare di nuovo a combattere insieme a tutta la compagnia «Littoria» sua. Venne a prenderci casa per casa, podere per podere uno per uno: «All’erta camerati, a conquistar l’Impero! Chi viene di voi?». «Comandi, qualcuno vegnerà» rispondemmo tutti quanti. Non è difatti che si dovesse insistere troppo per trovare volontari a Littoria. Anzi, parecchi li rimandarono pure indietro: «Siamo troppi». Quelli – le ripeto – ci avevano dato la terra e mo’ che la patria chiamava, tu manco volevi rispondere: «Volontario!»? Li abbiamo riempiti di volontari fino all’ultimo battaglione «M» della Rsi, fino alla X Mas. Ora lasci stare – le ripeto – che pure agli Abissini li chiamava la patria loro; anzi, eravamo noi che andavamo ad invadergliela. Ma noi credevamo così, punto e basta, è inutile stare ad insistere, il dramma della condizione umana è proprio questo: sei quasi perennemente condannato a vivere nel torto, pensando peraltro d’avere pure ragione. E noi mandammo zio Adelchi: «Toca a lù stavolta» perché era l’unico, dei fratelli grandi, che non fosse ancora sposato e con figli. E «Toca a mì stavolta» aveva detto subito lui stesso peraltro – prima ancora che i fratelli parlassero -perché qui c’era da lavorare dalla mattina alla sera e un po’ d’avventura, pensava lui, e vedere il mondo non gli avrebbe fatto male. E così quando il Barany venne a casa la sera a dire «Chi viene?», zio Pericle non lo fece neanche parlare e gli chiese solo: «Andrebbe bene l’Adelchi?».
«Certo che va bene l’Adelchi» rispose Barany, perché gli stava simpatico. E poi, diciamoci la verità, zio Adelchi era fatto proprio per la divisa. Ai Peruzzi le bestie – come si suole dire – ai Benassi i trattori, agli Adelchi i galloni. A zio Adelchi la divisa era sempre piaciuta. Fin da bambino non aveva fatto che dire alla madre, mia nonna: «Da grande voglio diventare carabiniere». O non so se fosse stata proprio lei, invece, a dirgli da piccolo: «Ah, tu bisogna proprio che fai il carabiniere». Lui era il cocco della nonna, il preferito. Lei se lo ricorderà sicuramente, era alto e moro moro. Nella nostra famiglia o biondi o mori – alternati quasi ogni due anni, maschi e femmine – un biondo ed un moro, un biondo ed un moro: zio Pericle biondo e zio Adelchi moro moro. E anche da piccoli non è che si prendessero molto, lo riempiva di pugni in testa mio zio Pericle, che invece era legatissimo a zio Iseo, quello venuto subito dopo zio Adelchi. La forza d’un leone però ce l’aveva anche zio Adelchi, e le spalle ampie, il sorriso largo sui denti bianchi, il viso perfetto con le ciglia scure, i capelli neri foltissimi col ciuffo ad onda che portava sempre da una parte – una criniera appunto, sempre curata e lucidissima di brillantina Linetti – e lo sguardo allegro e fiero che diceva al mondo: «Mondo, son qua per far contento te». E con questo sguardo -diceva mia zia Bìssola – pare che fosse uscito direttamente, già a suo tempo, dal ventre di sua madre. Come si faceva a non innamorarsene? Ora zio Adelchi lo sapeva benissimo, naturalmente – e lo sapeva benissimo anche mia nonna – che non era lui il primogenito. Il primo maschio da noi – quello in cui immediatamente dopo mio nonno risiedeva la massima potestas -era zio Temistocle, e il fatto che sua moglie non piacesse a mia nonna era secondario. Non le piaceva però se la teneva, era lei – volere o volare – la donna che avrebbe preso il suo posto. Poi appena arrivati qui e avuti due poderi e mio zio Temistocle il suo tutto per lui, mia nonna non ci aveva pensato un attimo a dirgli: «È il tuo e fai tutto per te, per parte tua». Lui aveva pure tentennato: «No, no, mamma. Siamo una famiglia sola, siamo pure tanti, continuiamo a fare tutti insieme una famiglia sola». «No, no, è giusto così» e mia nonna dentro di sé era al settimo cielo, perché con la moglie di Pericle invece andava d’amore e d’accordo, come ci andavano anche tutti i cognati eccetto le femmine. E così zio Temistocle aveva fatto famiglia per conto suo e a quel punto – come è giusto che fosse – subito dopo mio nonno la potestas era passata a zio Pericle, senza neanche bisogno di dirlo. Lo sapevamo già tutti. Lo sapeva quindi pure zio Adelchi di essere solo il terzo maschio, e mai gli è passato in mente di porlo in discussione. Anzi, quando appena divisi con zio Temistocle, zio Pericle aveva detto: «Va bene, mamma, adesso siamo qui, e terra nuova vita nuova. Da oggi in poi tutti i più giovani bisogna farli studiare, debbono diventare qualcuno, perché nessuno possa più imbrogliare i Peruzzi come hanno fatto gli Zorzi Vila», subito zio Adelchi aveva fatto cenno di sì, che lui era d’accordo. Pure il nonno da un canto diceva di sì con la testa. Solo mia nonna provò a dire: «Ma i schèi? Quanto ne costerà? Come faremo?».
«Faremo, faremo!» disse subito zio Adelchi, manco l’idea fosse stata la sua.
«E se n’i gà la testa?»
«Gliela faccio venire io a calci.»
E fu così che mandarono i miei zii più giovani a scuola. Quando stavamo su, sì e no che si faceva la seconda o terza elementare. Invece qui – finite le elementari al Borgo – ci mandarono tutti i giorni a Littoria in bicicletta, creature di dieci o dodici anni come zio Cesio e zia Ondina, sotto l’acqua d’inverno. E quando facevano storie, davvero zio Adelchi ce li mandava a calci: «L’è pel vostro bèn, desgrassià».
«Ma mì ago fredo!»
«Viaaa!» mandava uno strillo acuto allora, perché quando strillava – non so se gliel’ho detto – la voce gli si faceva aguzza.
[...]
Come dice, scusi? che il Barany però era un fascista?
Ho capito. Però è sempre un mio Antenato e quella notte che è caduto c’era pure mio zio Adelchi con lui sull’Amba Aradam. O meglio, non proprio sopra ma sulle falde. Sopra c’erano ancora gli etiopi – e tutto intorno – e se mio zio diceva di non avere mai visto i gas, diceva però anche che quella notte sull’Amba Aradam, nascosto in una fossa col compare Franchini, aveva sentito a un certo punto, a un rapido mutare del vento, un forte e persistente puzzo d’aglio e di cipolla che, lei sa, è l’odore appunto dell’iprite.
[...]
Erano passati tre mesi dall’attentato e mio zio Adelchi e il compare Franchini stavano tranquilli negli acquartieramenti. In un giorno di maggio però li hanno caricati sui camion e in serata – insieme ai colleghi loro – hanno circondato Debra Libanos, che era costituita da due grandi chiese in muratura e un migliaio di tucul in cui abitavano i religiosi. Nei giorni seguenti hanno fatto tutto un mucchio di questi preti, sottopreti, vescovi, abati, diaconi, seminaristi, studenti di teologia, chierichetti, monache, suore, educande e qualche pellegrino, e ne hanno portata una parte sulla riva di un canyon lì vicino – nella piana di Laga Wolde – in fondo al quale scorreva un fiume che era quasi secco. Li hanno fatti mettere in fila sullo strapiombo e con le mitragliatrici li hanno falciati tutti. Poi sono passati a dare i colpi di grazia, una spinta e giù nello strapiombo. Era il 21 maggio 1937 e alle quattro del pomeriggio lì da loro -da noi saranno state le tre – era tutto finito. Mio zio stava in un plotone di guardia messo di fianco alle mitragliatrici e doveva sparare con il moschetto a quelli che eventualmente provassero a scappare.
«Ma questi sono preti, compa’» faceva il povero Franchini.
«Sì, ma i xè rètici! Non l’hai sentito il cappellano? Tasi e spara Franchìn, non star farte sentire che qui ne cópa a nantri.»
Quelli avanzati invece – l’altra parte che era rimasta sotto sorveglianza a Debra Libanos – li abbiamo portati cinque giorni dopo a Engechà, verso Debra Berhàn, dove avevamo già scavato con le ruspe due grandi fosse. Ce li abbiamo messi davanti – erano quasi tutti diaconi questi: ragazzini, giovani seminaristi – e anche loro con le mitragliatrici e via.
«Ma questi so’ preti compa’, so’ chierichetti» continuava a fare piano piano, sconsolato, Franchini.
«Tasi Franchìn, tasi, maladéto!» imprecava mio zio.
L’avessero fatta a noi cattolici una cosa così, staremmo ancora a pregare tutti i giorni in piazza san Pietro. Li avremmo fatti tutti santi e io non la vorrei disilludere, ma guardi però che tra portare la democrazia in giro sulle canne dei fucili e portarci gli imperi, non c’è poi tanta differenza. Pure il Duce diceva di farlo per il bene loro: «Agh portèmo la civiltà».
Ora poi – come lei sa – in quell’impero non trovammo un solo chilo di ferro o di carbone, neanche una materia prima, non parliamo del petrolio. Petrolio ce n’era quanto ne avremmo voluto in Libia, ma non ci riuscì mai di trovarlo. Lo trovarono solo dopo. E anche di terra per farci emigrare i contadini ne trovammo quasi quanta l’oro il ferro il piombo, ossia niente. Le terre fertili erano poche, la maggior parte era pietraia. Dia retta a me: la prossima volta che l’aquila imperiale – con tanto di Imperium tra gli artigli – si rimette a svolazzare sui colli fatali nostri, ci conviene chiamare a raccolta l’Arci-caccia e farle sparare subito come al peggior colombaccio.
[...]
In Africa Orientale non è che fosse andata meglio che in quella Settentrionale. Subito dopo l’offensiva nostra difatti, gli inglesi avevano fatto affluire dall’India e dal Sudafrica rinforzi di uomini e mezzi. Truppe fresche e ben equipaggiate. Noi avevamo trecentomila uomini lì. Loro sessantamila. Ma non c’era paragone. L’aviazione nostra era rimasta indietro non solo come velocità, manovrabilità ed armamento dei velivoli; ma anche proprio come numero, perché molti dei vecchi aeroplani di Balbo – divenuti oramai inutilizzabili per l’usura – non erano stati sostituiti. E così le truppe a terra. Eravamo stati i primi a fare una guerra meccanizzata in Africa, usando autocarri e carri armati; ma pure quelli erano rimasti gli stessi. Anzi, non avevamo nemmeno i ricambi di gomme e camere d’aria. I pezzi d’artiglieria erano quasi tutti superati e il munizionamento risaliva in buona parte al 1918. Molte granate – una volta sparate – poi non esplodevano. Le lanciavi e «Puf», niente, non succedeva niente. Gli inglesi invece arrivarono armati fino ai denti e con tutte le armi e gli armamenti all’ultimo grido. Gli mancavano solo i Ray-Ban. Noi a piedi coi moschetti e loro con un mare d’aerei che li coprivano dal cielo, e in terra carri armati, autoblindo e camionette fuoristrada – le antesignane della Land Rover – con tanto di cannoncino e mitragliatrice. “Gazelle Force” la chiamavano. Nel gennaio del 1941 sferrarono un attacco simultaneo da nord e da sud. Erano sessantamila, le ripeto. Noi trecentomila. Ma trecentomila pellegrini. In Africa Orientale non abbiamo potuto chiamare in soccorso i tedeschi. Non potevano arrivare. Suez era chiuso anche per loro. Se no avremmo allungato l’agonia anche lì. Non arrivò nessun soccorso e neanche più un rifornimento dalla madrepatria. Resistemmo il più possibile e ci battemmo anche con valore. Il duca d’Aosta si asserragliò sull’Amba Alagi e resistette fino al 17 maggio 1941. Quando ci arrendemmo, gli inglesi ci concessero l’onore delle armi.
Il Duce disse: «Ritorneremo! L’impero sta là, è nostro e nessuno ce lo tocca. Mo’ vinciamo la guerra in Europa, gli spezziamo per sempre la schiena e poi andiamo lì e ce lo ripigliamo».
Che le debbo dire? Noi davvero gli credevamo ancora. Certo c’era il dispiacere e soprattutto il pensiero e l’ansia per quelli che erano lontani e di cui non si avevano notizie. Mica c’era internet allora – o i telefonini satellitari – e la posta aerea, lei capisce, se la supremazia inglese era totale non poteva certo passare. A un certo punto anche le comunicazioni radio per la truppa erano saltate. Mesi e mesi senza sapere niente. Solo i bollettini di guerra e i proclami del Duce: «Ritorneremo!». Ma che fine avessero fatto i miei zii, solo Dio lo sapeva, diceva mia nonna.

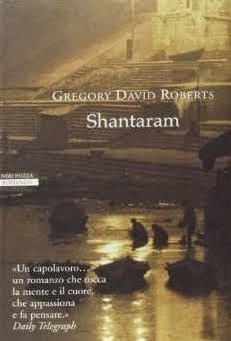






2 commenti:
Caro,
sto leggendo questo bellissimo libro.
Sono proprio qui:«Ma mì ago fredo!»
«Viaaa!» mandava uno strillo...
questa parte mi hai fatto ridere.
Quest'anno sono andata a Terracina, non conoscevo questa storia.
Un saluto da São Paulo.
Fatima
Ciao Fatima a questo punto il libro avrai finito di leggerlo. Se, come immagino, ti è piaciuto consiglialo a chi conosci. Ogni anno vengono pubblicati milioni di libri, la maggior parte dei quali merita solo di essere lasciato sullo scaffale. Canale Mussolini è un capolavoro che può far avvicinare alla lettura anche chi non ama leggere. Alla prossima
Posta un commento